Il punto di vista degli Abhidharma sulle patologie emozionali e relative cure

Spesso si dà per scontato che uno dei punti forti del buddismo sia l’abilità di offrire molte idee e tecniche che riguardano il campo emozionale. Dopotutto, il buddhismo mira allo sviluppo di stati mentali sani, come l’equanimità e la compassione, e alla liberazione della mente dagli stati mentali negativi, come l’aggrapparsi dualisticamente alle cose e la rabbia, dunque sembra ragionevole presumere che tale tradizione abbia sviluppato una ricca gamma di metodi rivolti al campo affettivo. Questa ipotesi si riflette in una quantità di opere contemporanee che esaminano i punti di contatto fra il buddhismo e la psicologia occidentale; ma cosa ci permette di darlo per scontato?
Risponderò offrendo una breve panoramica di alcune concezioni buddhiste nel campo affettivo e una disamina critica di questi punti di vista, senza dare affatto per scontato che sia facile tradurre i termini buddhisti nel nostro abituale lessico che riguarda la mente. Dopo una presentazione del concetto buddista di mente in generale e dopo averne esposto l’attinenza al campo affettivo, delineerò alcune posizioni buddhiste circa la mente, in particolare legate agli Abhidharma, ricco corpus testuale che raccoglie delle tipologie mentali di cui metterò in risalto la pertinenza rispetto alla moderna conoscenza delle emozioni. In ultimo, parlerò di alcune tecniche buddhiste che sono molto legate alla trasformazione della vita affettiva, e sollevano interrogativi attinenti a questo nostro incontro.
Il mio intervento è diverso da quello dei miei colleghi per il fatto che, più che esaminare delle scoperte empiriche, descrive essenzialmente un metodo filosofico; mi focalizzerò sull’analisi dei concetti buddhisti, che cercherò di presentare attraverso i termini che sono loro propri, per quanto possibile, senza dare per scontata la validità incondizionata delle prospettive scientifiche e filosofiche moderne. Credo che in un incontro come questo sia importante prendere sul serio le idee che il buddhismo ha sviluppato sulla mente, per quanto aliene possano inizialmente sembrare; altrimenti, il dialogo potrebbe finire per essere unilaterale, con gli scienziati che considerano le pratiche buddhiste come oggetto di studio e i praticanti buddhisti come cavie, invece che vederli come colleghi potenziali.
Emozioni e tipologie
Dunque, che idea si sono fatti i buddhisti sulle emozioni?
Lasciatemi cominciare con una doccia fredda: nel buddismo non c’è nessun concetto di emozione, nel senso proprio del termine! Con questa dichiarazione non intendo negare che il buddismo abbia molto da dire sulla vita affettiva, ma intendo sostenere che il concetto di emozione, così come noi lo conosciamo, praticamente non svolge alcun ruolo nelle dissertazioni sulla mente presenti nel buddhismo indiano e tibetano tradizionale. Nel vocabolario buddhista tradizionale non c’è neppure un termine che assomigli alla nostra nozione di emozione, sicché il nostro concetto di emozione, indirettamente, non viene dunque neppure riconosciuto. Questo vi potrà sorprendere, giacché il concetto di emozione sembra talmente lapalissiano e fondamentale nel nostro modo moderno di concepire noi stessi.
Possiamo immaginare persone che non hanno esattamente il nostro stesso vocabolario emozionale, ma è difficile concepire delle persone che non capiscono un concetto così fondamentale come quello di emozione. E tuttavia, a quanto pare questo è proprio il caso dei buddhisti, perché nei testi buddhisti tradizionali indiani e tibetani pare non esserci alcun termine che neppure si avvicini al nostro concetto di emozione. Questa assenza sorprendente, addirittura scioccante, certamente è affascinante: dimostra che l’idea di emozione, che pare così lampante, in realtà non lo è. I concetti mentali, persino uno tanto ovvio come quello di “emozione”, non sono dotati di un’esistenza indipendente, ma esistono e hanno un senso soltanto entro i confini di una tipologia mentale in cui vengono distinti rispetto ad altre categorie.
In Occidente, forse la più famosa di queste tipologie è la triplice visione dell’anima di Platone: “Una parte, diciamo, è quella con cui un uomo impara, un’altra è quella con cui prova rabbia. Ma la terza parte…la chiamiamo la parte dell’appetito, a causa degli intensi appetiti che prova per il mangiare, il bere, l’amore e ciò che a essi si accompagna”1. Per Platone, insomma, la mente si compone di tre parti: la ragione, le passioni, e gli appetiti. La prima è di aiuto agli umani per valutare le situazioni e giudicare che cosa sia utile, buono, e così via; ma spesso la mente viene diretta da altre forze: gli “appetiti”, appunto, come il desiderio del cibo, e thumos, quel principio focoso (come quando proviamo rabbia) che è poi stato interpretato come passione e, più tardi, come emozione. È soltanto in opposizione reciproca che queste parti della mente hanno un senso, quindi un concetto come quello di emozione avrà significato soltanto entro i confini di una tipologia mentale a sua volta collocata in un contesto culturale più largo, che cambia con la storia.
L’assenza del concetto di emozione nel vocabolario buddista suggerisce inoltre che i buddhisti debbano avere un modo molto diverso di comprendere la mente. Di che modo si tratta? Come si presenta, una tipica tipologia mentale buddhista? Per rispondere a questi interrogativi farò riferimento a una delle più antiche tradizioni buddhiste, quella degli Abhidharma. Prima di questo, però, dovrei sottolineare ancora che questa non è la visione buddhista della mente, bensì, più semplicemente, una visione buddhista. Il buddhismo è infatti una tradizione complessa, piena di sfaccettature, nella quale troviamo molte tipologie mentali. Il punto di vista che presenterò qui è soltanto una delle molte concezioni buddhiste, anche se è certamente fra le più condivise.
La tradizione degli Abhidharma
Gli Abhidharma sono una delle tradizioni testuali buddiste più antiche, risalente ai primi secoli dopo il Buddha (566-483 a.C.), quando gli insegnamenti ricchi di ispirazione del fondatore che si trovano nei sutra vennero sistematizzati. Gli Abhidharma, inizialmente redatti sotto forma di liste, contengono i primi testi in cui vengono trattati i concetti buddhisti, e in quanto tali sono stati la fonte della maggior parte degli sviluppi filosofici del buddhismo indiano. Ma gli Abhidharma non sono solo fonte dello sviluppo filosofico buddhista, perché almeno fino al VII-VIII secolo della nostra era sono rimasti un luogo nevralgico e vitale del pensiero buddhista, e ha continuato a evolversi.
È una tradizione così vasta che è impensabile anche solo immaginare di accennare, qui, a tale diversità; dunque mi semplificherò il compito, prendendo in considerazione soltanto alcuni fra i molti testi di questa tradizione così ricca e prolifera, e riferendomi soprattutto, anche se non esclusivamente, alle opere di Asanga e Vasubandhu, due pensatori indiani rispettivamente del IV e V secolo d.C. Farò anche riferimento, qua e là, all’Abhidharma theravada, che acquisì la sua forma canonica più o meno nello stesso periodo, grazie alle opere di Buddhaghosa.
Tutti questi personaggi sono vissuti in quella che viene spesso definita come “l’età dell’oro” del pensiero buddhista in India, quando la tradizione degli Abhidharma era all’apogeo. Analizzandone i punti salienti, resisterò alla tentazione di sviscerare quelli in cui le opinioni di questi grandi pensatori divergono per focalizzarmi, invece, sui punti generali sui quali sono perlopiù concordanti. L’argomento degli Abhidharma è analizzare l’esperienza sensoriale e il mondo oggetto di tale esperienza, con le sue componenti, in un linguaggio che eviti di postulare un soggetto unificato.
Questa analisi riguarda tutta la gamma dei fenomeni, da quelli materiali fino al nirvana. Ad esempio, ci sono elaborate dissertazioni sui quattro elementi primari e i quattro secondari che formano la materia; ci sono anche dei lunghi trattati su natura, scopo e tipologia delle pratiche soteriologiche prescritte dalla tradizione buddhista, e questo è un punto centrale degli Abhidharma.
Ma buona parte degli argomenti trattati riguardano l’analisi della mente e delle sue varie componenti; quindi, spesso si fa riferimento a questo corpus chiamandolo “psicologia buddhista”, un termine per certi versi un po’ fuorviante. Ed è questa la parte degli Abhidharma sulla quale verte il mio intervento.
Nell’esaminare l’esperienza, gli Abhidharma procedono in un modo caratteristico che può risultare sconcertante per chi non lo conosce, ma che riflette le sue origini storiche. Ciascun tipo di fenomeno preso in esame viene analizzato in termini di elementi fondamentali (dharma), che poi confluiscono in una lista, e vengono raggruppati nelle categorie appropriate. Dunque, spesso lo studio degli Abhidharma è imperniato su una serie di lunghe liste. È peraltro così che è cominciata la loro tradizione, una tecnica mnemonica costituita da liste di elementi astratti provenienti dai discorsi del Buddha. Credo che tutti conosciate la battuta: «I buddhisti non hanno un dio, ma di sicuro hanno delle liste»! Questo è ancor più vero per gli Abhidharma che per ogni altra tradizione buddhista.
Dunque, siete avvertiti. Nell’elaborare queste liste di componenti dell’esperienza e del mondo che è oggetto dell’esperienza, gli Abhidharma non soltanto rinverdiscono le proprie origini, ma incarnano anche una delle colonne portanti della filosofia buddhista, formata da due idee gemelle: la non-sostanzialità e l’origine interdipendente. In base a questa filosofia, i fenomeni oggetto dell’esperienza non sono sostanze unitarie e stabili, bensì formazioni complesse e instabili di elementi fondamentali che si manifestano in dipendenza da complessi nessi causali.
Questo vale, in particolar modo, per la persona, che non è un sé sostanziale ma un costrutto in divenire, dipendente da configurazioni complesse di componenti mentali e materiali (gli aggregati): un’analisi che non si limita alla persona, ma si applica ad altri oggetti, analizzando i quali si scopre che tutte le cose sono composte di elementi a loro volta scomponibili in elementi via via più piccoli e sempre meno complessi. Inoltre, e questo è molto importante, tali elementi basilari non vanno reificati: non bisogna cioè pensare che siano entità stabili, ma vanno visti come eventi momentanei, correlati dinamicamente, che per un istante manifestano e in un istante si dissolvono. Quando dunque gli Abhidharma analizzano la materia considerandola costituita da componenti di base, ritengono che tali componenti siano non tanto particelle stabili, come granelli di materia, quanto, invece, fuggevoli eventi materiali che si manifestano e si dissolvono rispetto all’esistere, dipendentemente da cause e condizioni. Analogamente, anche la mente viene analizzata e suddivisa in componenti o tipi fondamentali di eventi che costituiscono il fenomeno complesso che chiamiamo “mente”.
In ultimo, l’analisi propugnata dagli Abhidharma non è soltanto filosofica: ha anche un suo aspetto pratico, giacché mira a sostenere le pratiche soteriologiche raccomandate dalla tradizione. Le liste di eventi materiali e mentali vengono usate dai praticanti per informare e rinvigorire le loro pratiche: ad esempio, la lista dei fattori mentali che esamineremo brevemente è un aiuto prezioso in molti tipi di meditazione, in quanto offre un’idea chiara dei fattori che bisognerà sviluppare e di quelli che andranno invece eliminati. In tal modo gli Abhidharma non solo funzionano come fonte della filosofia buddhista, ma anche informano le pratiche centrali della tradizione e offrono loro un supporto, come vedremo in seguito.
Le posizioni degli Abhidharma circa la mente
È importante capire che cosa si intende per “mente”, perché questo termine è parecchio ambiguo. Secondo gli Abhidharma la mente non è né una struttura cerebrale né un meccanismo di elaborazione dell’informazione; non è neppure un organo che lavora per un sé. La mente è, piuttosto, considerata una dinamica cognitiva complessa che consiste in un succedersi di stati mentali momentanei e correlati. Questi stati sono, perlomeno in principio, disponibili fenomenologicamente, ossia possono essere osservati volgendo l’attenzione all’interno e constatando in quale modo sentiamo, percepiamo, pensiamo, ricordiamo e così via. Nel fare tutto questo, notiamo una quantità di stati di consapevolezza, e notiamo anche che questi stati mutano rapidamente: sono questi stati mentali che sorgono in rapida successione ad essere indentificati come elementi base della mente dalla tradizione degli Abhidharma.
Da questa caratterizzazione preliminare, dovrebbe essere chiaro, ormai, che nell’elaborare una teoria della mente gli Abhidharma si fondano soprattutto su quello che noi chiameremmo un approccio in prima persona. È attraverso l’introspezione che possiamo comprendere la mente, e non certo studiandola come un oggetto esterno o osservandone le manifestazioni esteriori. Questo approccio dell’Abhidharma non è dissimile dagli approcci di molti pensatori occidentali, come Franz Brentano, William James e Edmund Husserl, che concordano sul fatto che lo studio della mente debba basarsi sull’osservazione di stati mentali interiori. Tale approccio è ben descritto nella famosa dichiarazione di
James, il quale dice che, nello studio della mente «l’osservazione introspettiva è ciò su cui dobbiamo fare affidamento, in prima istanza, soprattutto e sempre». Come lo stesso James riconosceva, tuttavia, l’osservazione della mente, che sembra intuitivamente una cosa sensata, non è per nulla semplice, e solleva diversi interrogativi. Cosa significa osservare la mente? Chi osserva? Che cosa viene osservato? Si tratta di un’osservazione diretta, oppure mediata? Oltre a questi complessi interrogativi epistemologici, ve ne solo altri che riguardano l’affidabilità dell’osservazione.
Entro certi limiti tutti quanti siamo capaci di osservare la nostra mente, ma è chiaro che le nostre capacità, in questo campo, sono molto diverse. Se così è, quali osservazioni andranno considerate affidabili? Una questione importante per chi studia gli Abhidharma, per poter includere fra i propri dati non soltanto le intuizioni ordinarie, ma anche le osservazioni dei meditanti esperti. Ovviamente emergono differenze notevoli in queste osservazioni, anche se non sempre è altrettanto ovvio in che misura l’esperienza meditativa sia pertinente alle teorie buddhiste della mente, come vedremo fra poco.
Gli Abhidharma e il pensiero di James, il filosofo di Harvard, sono paragonabili non solo perché fanno entrambi affidamento sul metodo introspettivo: vi sono altre somiglianze sostanziali, la più importante delle quali, forse, è l’idea del flusso di coscienza.
Secondo gli Abhidharma, gli stati mentali non si manifestano separatamente, ma ciascuno emerge dal momento precedente di coscienza, dando adito a sua volta ad ulteriori momenti di coscienza, che, tutti insieme, formeranno un flusso o continuum mentale (santåna [sans.], rgyud [tib.]), molto simile alla “corrente di pensiero” di James. La metafora del flusso, o della corrente, è presente anche nella tradizione buddhista, nella quale viene citato il Buddha: «Il fiume non si ferma mai: non c’è un istante, un minuto, un’ora in cui il fiume si fermi, e così è per il flusso del pensiero».
Non c’è però da sorprendersi se fra James e gli Abhidharma sia anche necessario operare alcune distinzioni, che tuttavia ci condurranno nel cuore del nostro argomento. La prima differenza interessante per la ricerca moderna è la questione se gli stati mentali sorgano continuativamente o no. Il punto di vista di James è ben noto: secondo lui, «la coscienza non appare a se stessa tagliata a pezzettini». Il contenuto della coscienza può mutare, ma il movimento da uno stato all’altro è fluido, senza interruzione apparente. Su questo gli Abhidharma non sono d’accordo, sostenendo che, sebbene la mente muti rapidamente, le trasformazioni sono discontinue. Soltanto un osservatore non addestrato vedrà la mente come un flusso continuo. Un’osservazione più profonda, sostengono gli Abhidharma, rivelerà che il flusso di coscienza è formato da istanti di consapevolezza individuabili.
Diversi testi degli Abhidharma misurano addirittura la durata di questi istanti, e si presume siano fondati sull’osservazione empirica. Come ho già detto, tuttavia, queste affermazioni sono ben di rado unanimi e in questo caso le diverse tradizioni degli Abhidharma sono in stridente contrasto tra loro. Per esempio il Mahavibhasa, un testo importante dei primi secoli della nostra era, sostiene che un istante sia composto da centoventi momenti fondamentali; illustra inoltre la durata dell’istante, dicendo che corrisponde al tempo che impiega un filatore medio per agguantare un filo; secondo un altro testo, invece, questa misurazione è troppo grossolana, e un istante è la sessantaquattresima parte del tempo necessario per schioccare le dita, o per un battito di ciglia.
Sebbene queste misure differiscano tra loro, possiamo pensare che, data l’imprecisione delle misure temporali precedenti l’era moderna, alla fine esse non siano poi tanto discordi, giacché indicano un istante di consapevolezza di circa un centesimo di secondo, una durata comunque molto inferiore a quella della trasformazione degli stati cerebrali così come descritta nella neurologia moderna. Ma se consideriamo quest’altra affermazione, tratta da un testo di Abhidharma theravada, ove si dice che «nel tempo di un lampo, o di un battito di ciglia, possono trascorrere miliardi di istanti mentali», il riferimento riguarda una scala temporale standard nella tradizione theravada, che però è infinitamente più veloce.
Questa vistosa discrepanza ci mette la pulce nell’orecchio rispetto alle difficoltà che sempre abbiamo davanti ai resoconti fondati sull’osservazione: chi dobbiamo credere? Su quale tradizione dovremmo fare affidamento? Inoltre, non possiamo fare a meno di chiederci da dove vengano queste differenze: derivano dalle osservazione dei meditanti, o sono il risultato di elaborazioni teoretiche? È difficile giungere a una conclusione definitiva quando le differenze sono così marcate, ma mi sembra che non si tratti soltanto di mere osservazioni empiriche, bensì di dissertazioni teoretiche forse sostenute da resoconti derivati da osservazioni. Dunque bisognerà essere prudenti nel dare per scontato che questi testi si riferiscano soltanto a scoperte empiriche: anche se in alcuni casi può essere così, si tratta perlopiù di elaborazioni teoretiche che non vanno prese alla lettera. In ultimo, un noto testo degli Abhidharma sembra intorbidire ancor più le acque, dichiarando che la misura dell’istante è al di là della comprensione degli esseri comuni, e che soltanto gli essere illuminati possono misurarne la durata.
Dunque, non c’è da essere sorpresi che il testo ci lasci alle nostre congetture. Un’altra differenza significativa (e ancora più importante, per il nostro scopo) tra James e gli Abhidharma, è il modo in cui questi ultimi concepiscono le funzioni cognitive degli stati mentali. Negli Abhidharma, come per James, gli stati mentali sono intenzionali, ossia poggiano su oggetti che sembrano esistere in modo indipendente dagli stati mentali. Questa intenzionalità viene tuttavia analizzata in modo diverso dagli Abhidharma, che presentano uno schema che, per quel che ne so, è davvero unico. Prenderlo in esame significa avere l’opportunità di capire come questa tradizione concepisce gli stati affettivi.
Ogni stato mentale, come ho detto, poggia su un oggetto: una relazione cognitiva che gli Abhidharma descrivono dicendo che ha due aspetti. Il fattore o aspetto primario è quello della consapevolezza (citta [sans.], gtso sems [tib.]), la cui funzione è essere cosciente dell’oggetto, e il secondo aspetto è quello dei fattori mentali (caitesika [sans.], sems byung [tib.]) che hanno la funzione di caratterizzare la consapevolezza e determinarne la natura qualitativa in termini di piacevole o spiacevole, focalizzazione o assenza di focalizzazione, calma o agitazione, positivo o negativo, e così via. Nel suo commentario al sommario degli Abhidharma da lui stesso redatto, Vasubandhu spiega: «La cognizione o consapevolezza coglie la cosa in sé, e null’altro; i fattori mentali o dharma associati alla cognizione, come la sensazione eccetera, colgono caratteristiche speciali, speciali condizioni».
La visione fondamentale che sta dietro a quest’affermazione inusuale, è che gli stati mentali abbiano due tipi di funzioni cognitive: la prima è la consapevolezza di un oggetto (per esempio, il mio odorato è consapevole di un oggetto dolce), ma gli stati mentali non sono soltanto stati di mera consapevolezza, non sono soltanto specchi passivi in cui si riflettono gli oggetti; sono, invece, attivamente in relazione con i loro oggetti, che colgono come gradevoli o sgradevoli, avvicinandoli con un intento particolare, e così via. Nel mio esempio, la cognizione olfattiva di un oggetto dolce non è soltanto consapevole della dolcezza; coglie anche l’oggetto come gradevole, ne distingue alcune qualità (per esempio la consistenza), e poi lo categorizza come il mio cioccolato svizzero preferito. Questa caratterizzazione dell’oggetto è la funzione dei fattori mentali. Lo studio di questi fattori mentali è importante per il nostro scopo, perché è proprio fra essi che troveremo gli stati che noi occidentali descriviamo come emozioni. Ma prima di inoltrarci in questo cammino, vediamo di appropriarci solidamente di queste nozioni seguendo la procedura standard degli Abhidharma, ossia esaminando alcune delle liste in cui tali concetti vengono sviluppati.
Consapevolezza
Ciascuno stato mentale, come ho detto, si compone del fattore primario della consapevolezza e di diversi fattori mentali. Il fattore primario della consapevolezza, descritto anche con il termine di vijñana [sans.] o rnam shes [tib.], spesso tradotto come “coscienza” o “consapevolezza cognitiva”, è l’aspetto dello stato mentale che è consapevole dell’oggetto. È precisamente l’attività del conoscere l’oggetto, e non è uno strumento al servizio di un qualche agente, come per esempio un sé (che è considerato non esistente). Questa consapevolezza si limita a discernere l’oggetto; nel mio esempio, corrisponde al momento in cui percepisco il profumo di quello che si scoprirà essere il mio cioccolato svizzero preferito.
Vasubandhu, quindi, definisce la consapevolezza come «il mero cogliere un oggetto». In molti testi degli Abhidharma troviamo sei tipi di consapevolezza: cinque derivano dai cinque sensi fisici (la vista, l’udito, l’odorato, il gusto e il tatto, a cui va ad aggiungersi più la cognizione mentale. Ciascun tipo di cognizione sensoriale si produce dipendentemente dall’esistenza di una base sensoriale (ossia uno dei cinque sensi fisici) e di un oggetto: tale consapevolezza sorge momentaneamente, e subito cessa per essere sostituita da un altro istante di coscienza, e così via. Il sesto tipo di consapevolezza è invece mentale: gli Abhidharma lo considerano come se fosse un senso, non diversamente dai cinque sensi fisici, sebbene vi siano dei disaccordi circa il suo fondamento.
Alcuni testi di Abhidharma, come quelli di Asanga, sostengono che questi sei tipi di coscienza non esauriscono tutte le possibili forme di consapevolezza, e ne aggiungono altri due tipi: la coscienza-magazzino (alaya-vijñana [sans.], kun gzhi rnam shes [tib.]) e la coscienza afflittiva (klistamanas [sans.], nyon yid [tib.]). L’idea di una coscienza-magazzino si fonda sulla distinzione fra i sei tipi di consapevolezza, che vengono descritti come una consapevolezza cognitiva manifesta (pravrtti-vijñana [sans.], ‘jug shes [tib.]), e una forma di consapevolezza più continua, meno manifesta, chiamata appunto coscienza-magazzino perché contiene tutte le abitudini fondamentali, le tendenze, le inclinazioni, e il karma latente accumulato da un individuo: è diversa anche perché è subliminale, sicché perlopiù non viene notata. Soltanto in circostanze speciali, come durante uno svenimento, la sua presenza può essere notata, o perlomeno inferita. La coscienza afflittiva erroneamente prende tale coscienza per un sé, e questo forma il nucleo del nostro innato senso del sé.
Dal punto di vista buddhista, comunque, si tratta di una percezione distorta: tale credenza impone l’idea di unità dove in realtà non vi è altro che una molteplicità di eventi mentali o fisici correlati tra loro. Dunque, il senso di controllo che questo nucleo cognitivo della persona contiene è perlopiù ingannevole. Non c’è, insomma, nessun incaricato dei processi fisici o mentali, i quali si manifestano invece in virtù di cause e condizioni loro proprie, e non in seguito ai nostri capricci. La mente non è governata da nessuna unità centrale, ma da un concorrere di fattori la cui forza varia a seconda delle circostanze. Asanga, quindi, postula fino a otto tipi di coscienza. Sebbene l’esplorazione degli ultimi due tipi di coscienza esuli dal nostro campo di azione, si tratta di argomenti importanti, soprattutto nel contesto di un dialogo fra il buddhismo e le scienze cognitive.
È vero che tali nozioni sono legate a una particolare scuola del pensiero buddhista, la scuola Yogacara, sul cui punto di vista non necessariamente dobbiamo intrattenerci qui oggi, ed è vero che alcuni dei dettagli associati a questi concetti possono essere discutibili; tuttavia, vorrei sottolineare che le nozioni riguardanti questi due tipi di consapevolezza contengono alcune intuizioni importanti, senza le quali la comprensione profonda dei punti di vista buddhisti sulla mente non può dirsi completa.
I fattori mentali
I fattori mentali, comunque, non sono soltanto meri stati di consapevolezza: sono anche attivamente in relazione con i loro oggetti, definendoli come gradevoli o sgradevoli, approcciandoli con un atteggiamento particolare, e così via. Questa relazione attiva è compito dei fattori mentali, che sono quell’aspetto dello stato mentale che è incaricato della caratterizzazione dell’oggetto di cui si è consapevoli. Per dirla altrimenti, se la consapevolezza rende nota la mera presenza dell’oggetto, i fattori mentali rendono noti i particolari del contenuto della consapevolezza, definendo le caratteristiche e le condizioni speciali del suo oggetto.
È opera loro la caratterizzazione che coglie un oggetto come gradevole o sgradevole, e se questo cogliere è attento o distratto, se è quieto o agitato, e così via. Il termine che indica questi elementi della mente viene tradotto come “fattori”, ad indicare la vastità di significati che gli Abhidharma associano a questo termine, giacché la relazione fra la consapevolezza cognitiva e i fattori mentali è complessa. A volte vi viene descritta in modo diacronico, come una relazione causale e funzionale: i fattori fanno sì che la mente colga l’oggetto (lo percepisca) in modi particolari; altre volte, invece, gli Abhidharma sembrano voler sottolineare una prospettiva sincronica, secondo la quale la consapevolezza cognitiva e i fattori mentali coesistono e cooperano per espletare il medesimo compito cognitivo.
In base alla procedura abituale, gli Abhidharma studiano i fattori mentali redigendone una lista, descrivendo i modi in cui essi si manifestano e vengono a cessare, e raggruppandoli in apposite categorie. Ciascuna tradizione degli Abhidharma possiede una lista lievemente diversa. Qui, seguirò quella dei cinquantuno fattori mentali distribuiti in sei gruppi:
• cinque fattori onnipresenti;
• cinque fattori determinanti;
• cinque fattori mutevoli;
• undici fattori virtuosi;
• sei afflizioni-radice o principali;
• venti afflizioni secondarie.
La natura di questa complessa tipologia è più chiara quando ci si rende conto che i sei gruppi possono ulteriormente ridursi a tre. I primi tre gruppi contengono tutti i fattori neutri, ossia quelli che, potendo essere presenti in ogni stato mentale, positivo o negativo, non sono di per sé né positivi né negativi. Gli altri due gruppi sono invece piuttosto diversi tra loro: i fattori virtuosi da una parte, e le afflizioni dall’altra. Essi vengono determinati eticamente, e la loro stessa presenza qualifica lo stato mentale come virtuoso o non virtuoso.
La lista dei fattori, allora, diventa così:
• quattordici fattori neutri (cinque onnipresenti, cinque determinanti e quattro fattori mutevoli);
• undici fattori virtuosi;
• ventisei afflizioni (di cui sei principali e venti secondarie).
Da questo modo di raggruppare i fattori, diventa chiaro che la tipologia degli Abhidharma è esplicitamente etica, essendo organizzata intorno all’opposizione tra fattori virtuosi e afflittivi. È nelle categorie determinate eticamente che si trova la maggior parte dei fattori (trentasette in totale), perché i quattordici restanti sono le basi cognitive comuni a tutti i fattori eticamente determinati. Sebbene non sia questo il luogo per esplorare le molteplici dimensioni dell’etica nella tradizione buddhista, è necessario dire qualche parola sul carattere etico degli stati mentali. Per esempio, il tal carattere etico, come viene determinato? Per rispondere a questo interrogativo, potrebbe essere importante operare una distinzione tra etica e morale, distinzione che risale a Hegel, ed è poi stata sviluppata da pensatori contemporanei come Paul Ricoeur. In breve, la distinzione fra l’etica e la morale consiste in due campi della vita etica: la morale è il campo più limitato, quello delle invenzioni e delle regole, mentre l’etica propriamente detta riguarda la dimensione più globale di una vita vissuta secondo la pratica della virtù e orientata al bene.
Questa distinzione ci aiuta a capire la natura etica della tipologia mentale degli Abhidharma. Gli stati mentali possono essere suddivisi moralmente, in base all’essere virtuosi o non virtuosi; da questa prospettiva morale, la loro valenza positiva o negativa è stimata in termini di karma, sicché gli stati mentali virtuosi conducono a risultati karmici positivi in questa vita e nelle vite future, mentre quelli non virtuosi conducono a risultati negativi. Sebbene tale distinzione sia certamente presente nella tradizione degli Abhidharma, dove si trovano dissertazioni sulla natura degli stati mentali in termini di risultati karmici, questo non è tuttavia il modo principale in cui la natura dei fattori mentali viene affrontata: la distinzione che ho fatto fra i fattori virtuosi e afflittivi differisce da quella fra stati virtuosi e non virtuosi, anche se naturalmente vi sono delle sovrapposizioni.
I fattori mentali virtuosi non solo soltanto positivi eticamente, ma lo sono anche moralmente; i fattori afflittivi, invece, non hanno bisogno di essere anche non virtuosi: per esempio, questo vale per il fatto di aggrapparsi all’esistenza di un sé, cosa che dal punto di vista morale è neutra giacché non viola formalmente alcuna regola o ingiunzione, e tuttavia è afflittiva dal punto di vista etico, giacché mina le nostre capacità di vivere una vita virtuosa.
Che cosa s’intende, allora, per “eticamente virtuoso” o “eticamente afflittivo”? La distinzione si fonda su una visione eudemonica degli esseri umani, il cui primo scopo sarebbe conseguire la felicità, qui intesa non come piacere ma come uno stato di benessere e di espansione. Il benessere non è facile da conseguire dal momento che, solitamente, è difficile alimentare la felicità continuativamente. Tendiamo infatti a cadere in preda a certe tendenze o afflizioni, come l’aggrapparci a un sé, l’attaccamento, l’avversione, che ci conducono all’insoddisfazione e all’agitazione. Tali fattori sono afflittivi in quanto profondamente radicati dentro di noi anche se non scegliamo di alimentarli, e ci conducono alla sofferenza. Lo scopo della pratica buddhista è liberarci da queste compulsioni interiori in modo da poter condurre una buona vita, sviluppando virtù quali il distacco e la compassione.
È dunque in questo senso che gli Abhidharma operano la distinzione fra fattori virtuosi e afflittivi: i fattori virtuosi sono quelli che conducono a una pace e a una felicità durevoli; sono le “eccellenze”, come la compassione e il distacco, che favoriscono ciò che è buono, e anche lo costituiscono. Sono positivi nel senso che non ci vincolano ad atteggiamenti che conducono alla sofferenza; ci lasciano indisturbati, sicché possiamo incontrare apertamente la realtà con una prospettiva più rilassata e più libera. I fattori afflittivi, invece, disturbano la nostra mente, creando frustrazione, agitazione, e così via: questi sono gli ostacoli principali alla “buona vita” così come è intesa dalla tradizione buddhista. Asanga definisce le afflizioni in questo modo: «La caratteristica dell’afflizione è che, quando sorge, si presenta come un disturbo, e rende la mente e il corpo turbati». È in questa prospettiva etica che la tipologia degli Abhidharma va intesa; offre un’analisi delle condizioni interiori necessarie per vivere una buona vita, operando la distinzione fra fattori eticamente virtuosi e fattori afflittivi.
Alcune funzioni cognitive e affettive dei fattori mentali
Ora che abbiamo un’idea, a grandi linee, della tipologia degli Abhidharma, proviamo a concentrarci sui fattori mentali, delineandone alcune funzioni cognitive e affettive. Questo ci permetterà di capire come gli Abhidharma considerano il campo affettivo, e quale posto gli riservano nel panorama mentale generale. Cominciamo dai fattori neutri:
• cinque fattori onnipresenti: sensazione (vedana [sans.], tshor-ba [tib.]) identificazione (samjña [sans.], ’du-shes [tib.]), intenzione (cetana [sans.], sems-pa [tib.]), attenzione (manasikara [sans.], yid-la-byed [tib.]), contatto (sparìa [sans.], reg-pa [tib.]);
• cinque fattori determinanti: aspirazione (chanda [sans.], ‘dun pa [tib.]), determinazione o interesse (adhimoksa [sans.], mos-pa [tib.]), richiamo o presenza mentale (smrti [sans.], dran-pa [tib.]), concentrazione (samadhi [sans.], ting-nge-’dzin [tib.]), intelligenza (prajña [sans.], shes-rab [tib.]);
• quattro fattori mutevoli: sonno (middha [sans.], gnyid [tib.]), rammarico (kaukrtya [sans.], gyod-pa [tib.]), ragionamento o investigazione (vitarka [sans.], rtog-pa [tib.]), analisi (vicara [sans.], dpyod-pa [tib.]).
Questi fattori sono detti “neutri” nel senso che possono presentarsi negli stati eticamente positivi, eticamente negativi o eticamente neutri. Naturalmente ci sarebbe molto da dire su questa lista, che può sembrare composta da elementi davvero eterogenei. Qui, mi limiterò a poche osservazioni. Tra questi quattordici fattori, i primi cinque sono detti “onnipresenti” perché sono presenti in tutti gli stati mentali: persino in uno stato subliminale, come quello della coscienza-magazzino, questi cinque fattori sono presenti.
Gli altri nove non sono indispensabili per la prestazione di un compito cognitivo minimo (il cogliere un oggetto, anche in modo vago e indistinto), sicché sono presenti solo in alcuni stati mentali, non in tutti. Un aspetto che subito ci colpisce, in questa lista, è che il primo posto sia dato alla sensazione (vedana [sans.], tshor ba [tib.]). Da un lato, questa sua rilevanza riflette la visione fondamentale della tradizione, che considera gli esseri umani prima di tutto come esseri senzienti, e come tali essi non li distingue da altri tipi di esseri come gli animali, anche se naturalmente hanno abilità diverse. Nella tradizione buddhista, gli esseri sono prima di tutto senzienti, nel senso che la felicità e la sofferenza (nel senso più vasto dei termini) sono i loro problemi principali.
D’altro canto, questa importanza della sensazione riflette anche una visione tipica dell’ambito cognitivo che sottolinea il ruolo della spontanea attribuzione di un valore. Negli Abhidharma, uno stato mentale non è soltanto consapevolezza di un oggetto, ma ne è contemporaneamente la valutazione; tale valutazione è la funzione del tipo di sensazione che accompagna la consapevolezza, facendo si che l’oggetto sia esperito come gradevole, sgradevole o neutro. Tale fattore svolge un ruolo centrale nel determinare le nostre reazioni agli eventi che incontriamo, giacché perlopiù non ci accade di percepire in prima battuta un oggetto, e poi di sentirci a nostro agio o a disagio rispetto a esso in base a una serie di giudizi riflessivi, bensì accade che la valutazione sia già incorporata nelle nostre esperienze.
Possiamo usare delle riflessioni per formulare dei giudizi più obiettivi, ma le riflessioni operano perlopiù come correttivi delle valutazioni spontanee. Negli Abhidharma, la valutazione spontanea è fondata sul modo in cui “sentiamo” l’oggetto: è questa, la funzione della sensazione. Gli Abhidharma la paragonano a un re che assaggia il cibo preparato dal suo seguito (gli altri fattori mentali; la sensazione è descritta anche come strettamente connessa ad alcuni dei fattori afflittivi (e affettivi) che esamineremo fra breve.
Questo, comunque, non è l’unico fattore importante: ve ne sono diversi altri che meritano di essere brevemente menzionati. L’intenzione (cetana [sans.], sems-pa [tib.]), per esempio, è un fattore centrale onnipresente che determina il carattere morale (non il carattere etico) e lo stato mentale. Ciascuno stato mentale si rivolge a un oggetto con un’intenzione, con una motivazione che può essere o no nota alla persona. Tale intenzione determinerà la natura karmica dello stato mentale: se sarà virtuoso, non virtuoso o neutro. L’intenzione è collegata al fatto di raggiungere una meta, e dunque viene anche intesa come un punto focale organizzativo degli altri fattori. È paragonata a un mastro falegname che, intanto che svolge il suo compito, fa lavorare anche gli altri falegnami. Sono molto significativi anche tre altri fattori, particolarmente attinenti al discorso sugli stati meditativi. Il primo è l’attenzione (manasikara [sans.], yid-la-byed [tib.]), uno dei cinque fattori onnipresenti. È l’abilità della mente di rivolgersi a un oggetto. Bikkhu Bodhi spiega: «L’attenzione è il fattore mentale grazie al quale la mente avverte l’oggetto, e in virtù del quale l’oggetto diventa presente alla coscienza.
La sua caratteristica è quella di condurre all’oggetto gli stati mentali associati; la sua funzione è aggiogarveli»24. Ogni stato mentale ha almeno una quantità minima di focalizzazione sul suo oggetto, di conseguenza l’attenzione è un fattore onnipresente. Così non avviene per altri due fattori correlati: la concentrazione (samadhi [sans.], ting-nge-’dzin [tib.]), ossia l’abilità della mente di dimorare sul suo oggetto in modo univoco, e la presenza mentale (smrti [sans.], dran-pa [tib.]), tradotta anche come “richiamo”, che è invece l’abilità della mente di tenere a fuoco un oggetto senza distrarsene, senza dimenticarlo, senza tentennare o senza vagare per aria, lontano da esso.
Queste abilità non sono presenti in tutti gli stati mentali; la concentrazione differisce dall’attenzione nella misura in cui comporta l’abilità mentale non solo di cogliere un oggetto, ma anche di alimentare continuativamente l’attenzione nel tempo. Analogamente, la presenza mentale è più che cogliere semplicemente l’oggetto, giacché comporta la capacità della mente di tenere a fuoco l’oggetto, evitando che esso le sfugga nell’oblio. Entrambi i fattori, che sono vitali nella pratica della meditazione buddhista, sono inclusi tra i fattori determinanti; non sono onnipresenti, ma presenti soltanto quando l’oggetto viene colto con un certo grado di chiarezza o di focalizzazione continuativa. L’argomento dei fattori mentali, tuttavia, non può fermarsi qui, giacché abbiamo ancora da vedere come gli Abhidharma concettualizzano gli stati che noi chiameremmo “emozioni”. A questo scopo, dobbiamo esaminare i fattori determinati eticamente, a cominciare dagli undici fattori virtuosi:
• gli undici fattori virtuosi: la fiducia/fede, il pudore o rispetto nei confronti di se stessi, la considerazione o rispetto nei confronti degli altri, l’impegno entusiastico, la flessibilità, la coscienziosità, il non-attaccamento o distacco, l’assenza di odio (l’amorevolezza), la saggezza o assenza di stupidità, l’equanimità o imparzialità, e il non arrecare danno (la compassione). Sebbene ci sia molto da dire su di essi, mi limiterò a sottolineare la presenza di diversi fattori positivi che noi descriveremmo come emozioni, a cominciare dall’amorevolezza e dalla compassione. Entrambe appartengono a quello che noi chiameremmo il campo affettivo, sebbene qui vengano intese non in termini di affettività bensì in relazione al loro carattere etico, e perciò siano raggruppate con altri fattori, come la saggezza e la coscienziosità, che sono più cognitivi che affettivi.
Negli Abhidharma, tutti questi fattori sono raggruppati insieme: sono tutti positivi nel senso che promuovono il benessere e la libertà dalle compulsioni interiori che conducono alla sofferenza. È precisamente questa la natura dell’ultimo gruppo, i fattori afflittivi; è senza dubbio il più numeroso, ed è quindi oggetto di particolare attenzione all’interno della tipologia. Questo gruppo è anche quello in cui troviamo la maggior parte degli stati che noi chiameremmo emozioni. Ecco la lista:
• le sei afflizioni-radice (o principali): attaccamento, collera, ignoranza, orgoglio, dubbio negativo e le opinioni distorte;
• le venti afflizioni secondarie: bellicosità, rancore, ipocrisia, disprezzo o malevolenza, gelosia o invidia, avarizia, circonvenzione, dissimulazione, sufficienza o alterigia, crudeltà, assenza di ritegno o rispetto per se stessi, assenza di rispetto per gli altri, inerzia mentale, agitazione mentale, perplessità o mancanza di fiducia/fede, pigrizia, negligenza, oblio, disattenzione, percezione errata. Anche qui notiamo che la lista contiene fattori che sembrano piuttosto eterogenei; alcuni, come l’ignoranza, sono chiaramente cognitivi, mentre altri, come collera e gelosia, sono più di ordine affettivo. Gli Abhidharma li raggruppano tutti insieme, tuttavia, per la semplice ragione che sono afflittivi: disturbano, cioè, la mente, rendendola irrequieta e agitata. Inoltre la costringono e la vincolano, impedendoci di sviluppare atteggiamenti più positivi.
Questo può essere evidente nel caso dell’attaccamento e della rabbia, che ci conducono direttamente all’insoddisfazione, alla frustrazione e all’irrequietezza; meno evidente è invece il ruolo afflittivo dell’ignoranza (ossia il nostro ingannevole, innato senso di un sé), ma ciò nonostante essa svolge un ruolo centrale perché causa di fattori afflittivi molto più evidenti. Prima di continuare, vorrei riflettere sul primo punto: la non esistenza di emozioni negli Abhidharma. Come abbiamo visto, nella tipologia vi sono molti elementi che possiamo identificare come emozioni: collera, orgoglio, gelosia, amorevolezza e compassione, ma non vi è alcuna categoria che sia direttamente collegata alla nostra nozione di emozione. La maggior parte dei fattori positivi non sono ciò che noi definiremmo emozioni, e sebbene molti dei fattori negativi siano di tipo affettivo, non tutti lo sono.
Ad esempio, l’ignoranza e il dubbio negativo non sono emozioni; analogamente, il desiderio o attaccamento di solito non viene inteso come emozione, sebbene questo meriti una riflessione ulteriore. È dunque chiaro che gli Abhidharma non riconoscono il concetto di emozione; non vi è alcuna categoria degli Abhidharma che possa essere usata per tradurre il nostro concetto di emozione, e dunque il nostro concetto di emozione è difficile da usare quando si traduce la terminologia degli Abhidharma. Il metodo usato dagli Abhidharma per tagliare la torta della mente differisce dalle tipologie occidentali, nelle quali compare il concetto di emozione; sottolinea la distinzione fra fattori virtuosi e afflittivi, più che opporre gli elementi razionali e irrazionali della psiche.
Le emozioni e i loro rimedi
Gli Abhidharma non si accontentano di operare queste distinzioni soltanto, ma spiegano anche la genesi di questi fattori e offrono una ricca varietà di rimedi. Esaminando la genesi delle afflizioni, gli Abhidharma mettono a fuoco la stretta connessione fra i fattori afflittivi e la sensazione. L’onnipresente fattore della sensazione è alla radice dei nostri atteggiamenti valutativi spontanei, ed è in stretto contatto con ciò che noi descriveremmo come emozioni.
Negli Abhidharma, questa connessione fra sensazione e valutazione spontanea è il punto di partenza delle reazioni patologiche che ci conducono alla sofferenza. Perché, quando abbiamo un’esperienza gradevole, non la consideriamo come una fuggevole espressione della nostra capacità di provare sensazioni, bensì, sulla base del nostro innato senso di un sé, ci appropriamo della sensazione e poi ci attacchiamo a essa: proviamo il desiderio di estenderla, di intensificarne la piacevolezza, e temiamo di venirne separati. Analogamente, reagiamo con rabbia e avversione quando incontriamo una sensazione sgradevole: vediamo quell’esperienza non come qualcosa che semplicemente non ci piace, ma come un vero attentato al nostro “sé”, e cerchiamo di proteggerci da essa, respingendola con tutta la forza possibile, finendo così per essere sconvolti e invischiati nelle nostre intense reazioni di rifiuto.
Vorrei sottolineare che secondo gli Abhidharma il problema non è tanto nelle sensazioni gradevoli o sgradevoli, le quali sono semplicemente dovute al fatto che noi siamo degli esseri senzienti, e in tal senso sono necessarie alla vita, giacché senza di esse non potremmo fare le valutazioni necessarie alla sopravvivenza. Il nostro modo di funzionare nel mondo non è uguale a quello di un computer, che considera tutte le opzioni e poi sceglie quella giusta; noi agiamo piuttosto in base alle nostre reazioni spontanee alle esperienze, e in questo non c’è niente di male. Non c’è niente di male neanche nell’intraprendere un’azione nei confronti dei problemi che viviamo; ma le azioni hanno bisogno di fattori motivanti, che spesso sono di natura affettiva, e questo è il punto cruciale del problema. Anche se non è sempre vero che tutte le reazioni affettive spontanee siano negative, alcune lo sono, indubbiamente.
l punto cruciale è dunque distinguere gli stati positivi da quelli negativi, come fanno gli Abhidharma. Ma è altrettanto cruciale prendere coscienza dei modi in cui queste reazioni negative spontanee si manifestano. Ed è qui che interviene il legame essenziale con la sensazione. In qualità di esseri senzienti, abbiamo esperienze piacevoli e spiacevoli sulla base delle quali poi agiamo. Il problema emerge dal fatto che tendiamo a strafare, nelle reazioni, provando attaccamento per le sensazioni gradevoli e respingendo violentemente quelle sgradevoli.
Questi atteggiamenti non sono necessari per le nostre abilità valutative, e sono invece delle super-reazioni di tipo patologico. Voglio dire che, per bermi un espresso all’italiana, non c’è bisogno che mi faccia venire l’ossessione dell’espresso. Basta che mi limiti a notare la sensazione estremamente piacevole che mi viene da questa deliziosa bevanda, e che poi a questo segua l’azione appropriata. Analogamente, non c’è bisogno che mi perda in deliranti concioni sulla mia nemesi politica: basterà che comprenda quali danni sta facendo il mio avversario perché in base a questo io agisca.
Invece, perlopiù, reagisco con attaccamento e con rabbia, e intanto che faccio così esagero l’aspetto piacevole o spiacevole dell’oggetto della mia esperienza, costruendomi una ragnatela di invischiamenti emozionali e cognitivi. Il mio caffè non è solo un buon caffè, e la mia nemesi politica non è solo un cattivo leader; finiscono per acquisire, per me, proporzioni straordinarie, tali da occupare tutti i miei pensieri. Tuttavia, tali atteggiamenti non derivano dal fatto che io abbia scelto di alimentarli, in base a un giudizio ponderato; semplicemente si manifestano da soli, e soverchiano la mia mente. Essendo profondamente radicati dentro di me, sorgono in modo automatico, senza che io abbia tanta scelta, anche quando sono al corrente della cosa. È proprio per questo che vengono chiamati “fattori afflittivi”. Negli Abhidharma la connessione fra le sensazioni e le afflizioni è cruciale: è proprio qui che, sulla base della nostra percezione errata di un sé, rimaniamo invischiati negli atteggiamenti compulsivi che ci conducono alla sofferenza. Dal momento che non abbiamo controllo su questi atteggiamenti, non basterà sperare che se ne vadano; per liberarci da tali patologie, bisogna scovare dei metodi per trasformare il nostro processo cognitivo.
Ed è qui che l’analisi dei fattori mentali che troviamo negli Abhidharma acquisisce un significato pratico: non è soltanto una dissertazione teorica, ma informa di sé e sostiene molti tipi di meditazione raccomandati dalla tradizione buddhista quali rimedi per le patologie summenzionate. Quando si mettono in atto questi rimedi attraverso la meditazione, gli ostacoli al nostro benessere, ossia i fattori afflittivi, vengono eliminati, e le virtù che costituiscono la “buona vita”, sviluppate. Le pratiche meditative operano in molti modi, che possono però essere riassunti sotto due voci: alcune meditazioni fungono da antidoto ai fattori negativi; li controbilanciano sviluppando l’atteggiamento positivo opposto, secondo il detto di Spinosa per cui «un sentimento non può essere limitato né eliminato se non da un sentimento opposto, più forte». Ad esempio, la meditazione sull’amorevolezza è l’antidoto alla rabbia; la meditazione sull’impermanenza, quello all’attaccamento. Tali antidoti hanno l’effetto di minare gli atteggiamenti ai quali si oppongono.
Se permeo la mente di un atteggiamento amorevole non c’è più posto per la rabbia, che viene respinta e temporaneamente eliminata. Ma sebbene i risultati di questa pratica vadano ben oltre il tempo della meditazione, essa non offre una soluzione finale al problema della rabbia: può eliminarla temporaneamente, ma alla fine ritornerà a meno che non si faccia qualcosa di più drastico. Ed è questo secondo approccio, più radicale, che si trova al centro della seconda categoria di pratiche meditative, più specifiche, queste, della tradizione buddhista. Tali pratiche non si limitano a reprimere gli atteggiamenti indesiderati, ma finiscono per eliminarli del tutto dal nostro flusso di coscienza. Tale liberazione dalle afflizioni è, di fatto, la meta stessa della pratica buddhista. La si può conseguire attraverso un triplice addestramento, riguardante la morale (l’osservanza dei precetti), la concentrazione (lo sviluppo di un atteggiamento presente e ben focalizzato) e la saggezza (quella visione penetrante interiore, liberatoria, che si sviluppa sulla base della concentrazione e della presenza mentale).
Questo processo liberatorio è imperniato sul fatto di poter rinforzare alcuni dei fattori che abbiamo esaminato. Ad esempio, la pratica della concentrazione univoca rafforza la nostra abilità di focalizzarci su un oggetto di nostra scelta, e di conseguenza anche il fattore mentale della concentrazione, sebbene influisca anche su altri fattori come l’attenzione, la coscienziosità e la flessibilità. Questo rafforzamento è particolarmente visibile nel caso della presenza mentale (smrti [sans.], dran-pa [tib.]), o “richiamo”, l’abilità di tenere a fuoco un oggetto senza dimenticarsene o senza distrarsene: la presenza mentale è considerata particolarmente importante quando si tratta di affrontare le afflizioni, giacché sviluppandola riusciremo a interrompere il contatto con le nostre sensazioni afflittive. E sebbene questa non sia ancora la meta ultima, è un passo importante nel favorire quel tipo di libertà che i buddisti vanno cercando nella loro pratica. La libertà ultima si deve allo sviluppo continuativo della visione penetrante della non-esistenza del sé.
Quando questo punto di vista ci impregna totalmente, allora la radice stessa delle afflizioni, che è l’aggrapparsi a un sé, si indebolisce e, alla fine, viene interamente eliminata. In una mente liberata dall’idea del sé non vi è più alcuna base per provare attaccamento o avversione, non c’è nessuno a cui attaccarsi e nessuno da proteggere attraverso la collera. Il conseguimento di uno stato mentale di questo tipo è l’apogeo del programma di liberazione degli Abhidharma; è lo stato della salute mentale assoluta, dove le patologie dei fattori afflittivi sono eliminate. Chi lo consegue è allora libero di alimentare atteggiamenti più positivi, e in particolare i fattori virtuosi, come l’amorevolezza e la compassione.
Interrogativi conclusivi
Questa mia breve panoramica sulla mente vista dal buddismo e sul modo in cui la tradizione degli Abhidharma considera il campo affettivo suscita diversi interrogativi, e qualcuno di essi, forse, può definirsi una vera sfida; interrogativi che condividerò con voi, a mo’ di conclusione. In primo luogo, dovrebbe essere chiaro che gli Abhidharma hanno una visione della mente in generale, e del campo affettivo in particolare, molto diversa dalla nostra; non riconoscono agli stati come la rabbia, la gelosia o la compassione alcuna categoria a se stante rispetto alle altre funzioni mentali. Ciò non vuol dire che ovviamente questi fattori vengano ignorati, ma piuttosto che gli Abhidharma li integrano in altre categorie, eticamente determinate.
Tale fenomenologia della vita affettiva può essere paragonata alle visioni che le discipline scientifiche moderne hanno della sfera emotiva? È davvero importante considerare l’ambito affettivo come costituito da esplosioni di eventi di breve durata e distinti, o sarebbe di maggiore utilità pensare a una visione più vasta, in cui le emozioni siano integrate in altre funzioni cognitive, con possibili diramazioni etiche? In secondo luogo, le discipline scientifiche moderne, come la neuroscienza, quale tipo di luce possono gettare su alcuni dei punti cruciali sollevati dagli Abhidharma, come la stretta relazione fra sensazioni e afflizioni?
Questi fattori negativi spesso possono rivelarsi piuttosto distruttivi, e dunque sviluppare dei metodi per affrontarli è importante. Possono, le discipline moderne, aiutarci a illuminare i modi in cui gli esseri umani affrontano la connessione fra sensazioni e afflizioni, allo scopo di ottenere una maggiore libertà? E, più generalmente, possono queste discipline contribuire a un’ulteriore spiegazione di come le pratiche buddhiste riescano effettivamente riuscire a controbilanciare alcune afflizioni? In ultimo, vi è una qualche possibilità di scoprire dei correlati neurologici relativi alla distinzione fra i fattori virtuosi e afflittivi? Si tratta di una distinzione meramente filosofica, oppure ha una sua base neurologica? In terzo luogo, come abbiamo visto, gli Abhidharma sono fondati su una netta distinzione etica fra stati positivi e negativi. Questa dominante etica solleva, per me, un interrogativo: è possibile separare lo studio degli affetti dalle preoccupazioni di ordine etico?
Gli affetti nascono dai nostri atteggiamenti valutativi, spontanei o no; dunque essi sono carichi di valori. È possibile studiare gli affetti nati da tali valutazioni senza considerare i valori che essi riflettono? E se dobbiamo considerare i valori nello studio delle emozioni, possiamo allora ignorare le considerazioni etiche?
NOTE
1. Platone, La Repubblica, 9.580d [BUR, Milano 1996]; la traduzione è nostra.
2. Per farsi un’idea delle origini dell’Abhidharma, cfr. Rupert Gethin, “The Matrikas: Memorization, Mindfulness and the List”, in In the Mirror of Memory: Reflections on Mindfulness and Remembrance in Indian and Tibetan Buddhism, a cura di Janet Gyatso, State University of New York Press, Albany 1992, pp. 149–172.
3. Buddhaghosa è autore dei commentari sui sette testi canonici dell’Abhidharma, e in particolare del famoso Atthasalini, un commentario sulla sezione del Dhammasangani dell’Abhidharma. Il testo a cui si fa riferimento nell’intervento di Fallace è l’Abhidhammattha Sangaha di Anurudha, una raccolta medievale delle opere di Buddhaghosa.
4. Louis de la Vallée Poussin, L’Abhidharmakosha de Vasubandhu, Institut Belge des Hautes Etudes Chinoises, Brussels 1971, 1:22. La nostra traduzione si è basata su quella resa da Wallace.
5. Per una breve ma profonda disquisizione sull’idea del buddismo quale psicologia, cfr. Luis O. Gomez, “Psychology”, in Encyclopedia of Buddhism, a cura di Robert E. Buswell, Jr., Macmillan, New York 2004, pp. 678–692.
6. William James, The Principles of Psychology (1891), Harvard University Press, Cambridge 1983, 185 [trad. it.: Principi di psicologia, Mondadori, Milano 1998].
7. Ibid., p. 233.
8. Anguttara 4, p. 137. Citato da Louis de la Vallée Poussin, “Notes sur le moment ou ksana des bouddhistes”, in Essays on Time, a cura di Hari S. Prasad, Sri Satguru, Delhi 1991, p. 69. La nostra traduzione si è basata su quella resa daWallace.
9. James, Principles of Psychology, op.cit., p. 233.
10. Poussin, “Notes sur le moment”, op.cit., pp. 70–71.
11. Bikkhu Bodhi (a cura di), A Comprehensive Manual of Abhidharma, Buddhist Publication Society, Kandy 1993, p. 156.
12. Poussin, “Notes sur le moment,” op.cit., p. 73. A cura di Anne Harrington 156 e Arthur Zajonc
13. Poussin, L’Abhidharmakosha, 1:30. La nostra traduzione si è basata su quella resa daWallace.
14. Ibid.
15. Per una vasta dissertazione sulla natura di questo sesto tipo di coscienza, cfr. Herbert V. Günther, Philosophy and Psychology in the Abhidharma, Shambhala, Berkeley 1976, pp. 20–30.
16. Walpola Rahula, Le compendium de la super-doctrine d’Asanga, Ecole Française d’Extrême Orient, Paris 1971.
17. Sebbene l’Abhidharma theravada non riconosca una coscienza- magazzino a sé stante, il suo concetto di bhavanga citta, la coscienza che è elemento costituente della vita, è alquanto simile. Per una trattazione delle complessità del bhavanga, cfr. William S. Waldron, The Buddhist Unconscious, Routledge Curzon, London 2003, pp. 81–87.
18. Per ulteriori dettagli sull’argomento, cfr. Waldron, Buddhist Unconscious, op.cit.
19. Vengono infatti descritti come congiunti (sampayutta [sans.], mtshungs ldan [tib.]) in quanto simultanei e dotati di una medesima base sensoriale, del medesimo oggetto, del medesimo aspetto o modo di cogliere l’oggetto, e della medesima sostanza (nel senso che possono esserci solo un tipo di coscienza e un tipo di fattore mentale alla volta). Cfr. Waldron, Buddhist Unconscious, op.cit., p. 205. 20. Questa lista, che è un classico della tradizione tibetana, è basata sull’Abhidharma-samuccaya di Asanga, nella quale si trovano, però, cinquantadue fattori. Rahula, Compendium de la super-doctrine, op. cit., p. 7. Per una trattazione più elaborata di tale lista, cfr. Geshe Rabten, The Mind and Its Functions (1978), Rabten Choeling, Mt. Pélerin 1992, e Elizabeth Napper, Mind in Tibetan Buddhism, Snow Lion, Ithaca 1980. Per le liste provenienti da alcune altre tradizioni, cfr. Bodhi, Comprehensive Manual, op. cit., pp. 76–79, e Poussin, L’Abhidharmakosha, op. cit., 2: pp. 150–178. 21. Paul Ricoeur, Oneself as Another, University of Chicago Press, Chicago 1992. 22. Rahula, Compendium de la super doctrine, p. 70. La nostra traduzione si è basata su quella resa daWallace.
23. Jamphel Samphel, “bLo rig[s] gi rnam bzhag nyer mkho kun ‘dus blo gsar mig ‘byed” [tib.], 11a, in E. Napper, Mind in Tibetan Buddhism, op. cit. La traduzione italiana della lista dei fattori ha tenuto conto di quella presentata nel Dizionario del Buddhismo di Philippe Cornu, Bruno Mondadori, Milano 2003; abbiamo volutamente aggiunto i termini sanscriti e tibetani perché esistono traduzioni diverse nella nostra lingua (N.d.R).
24. Bodhi, Comprehensive Manual, op. cit., 80. 24. Ibid., p. 81.
25. Samphel, “bLo rig[s] gi rnam bzhag”, op. cit., 11b.
26. Per una disquisizione circa il fatto che compassione e amorevolezza siano o no emozioni, cfr. Georges Dreyfus, “Is Compassion an Emotion? A Cross-Cultural Exploration of Mental Typologies”, in Visions of Compassion: Western Scientists and Tibetan Buddhists Examine Human Nature, a cura di Richard J. Davidson e Anne Harrington, Oxford University Press, Oxford 2002.
27. Samphel, “bLo rig[s] gi rnam bzhag”, op. cit., 12a.
28. Spinoza, Etica, 4.7.
Tratto da “Il Buddha in Laboratorio. Dialoghi fra il Dalai Lama e la scienza sulla natura della mente”. A cura di Anne Harrington e Arthur Zajonc. Edizioni Amrita. Torino. 2008
Copyright Edizioni Amrita. Per gentile concessione.











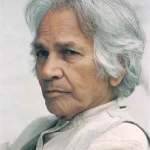


Dunque emozione ed inconscio (inteso come nella tradizione psicanalitica freudiana – meno in quella junghiana – e un po’ grossolanamente assimilabile alla coscienza magazzino della tradizione buddista) sono termini comprensibili solo tenendo conto che una premessa fondamentale del linguaggio nel cosi’ detto mondo “occidentale” e’ quella dell’ esistenza di un se autonomo , convinzione che gli Abhidharma considerano il fattore afflittivo principale e che invece e’ il principio fondante della nostra cultura ed un elemento di grave interferenza in ogni approccio che un uomo educato nella tradizione “greco-cristiana” tenti ad una visione del mondo in cui il concetto di io autonomo sia considerato l’ errore gnoseologico di fondo.
L’ articolo spiega in modo veramente efficace questa differenza fondamentale nelle due visioni del mondo, differenza che si trasferisce di pie’ pari nel linguaggio non consentendo addirittura la nascita di parole che siano omologabili, specie quando si tratta di termini di natura psicologica: la psiche nel mondo occidentale e’ riconducibile ad un’ entita’ di riferimento rappresentata dall’ io separato , che nella visione buddista e’ considerata invece una sorta di allucinazione.
Meno convincente e piu’ convenzionale mi sembra l’ articolo quando auspica lo studio dei correlati neurofisiologici degli stati mentali afflittivi.
Mi sembra il solito motivo ormai un po’ logoro del buddismo americano di ispirazione tibetana (alla Goleman per intenderci) che finisce nello sconfinare in uno scientismo divulgativo un po’ sempliciotto, come spesso sono i forzosi sincretismi di oltre oceano.
In America, ai candidati alla selezione della giuria di un processo viene chiesto se sono in grado di separare i sentimenti dalle decisioni razionali. Se qualcuno risponde no, viene immediatamente scartato dal gruppo dei potenziali giurati. La nostra cultura, inoltre, considera lo stupro un atto dettato dall’istinto e l’omicidio un crimine passionale. E quando poi importiamo dall’Oriente filosofie che considerano l’istinto e la passione come qualcosa da sradicare e uccidere, perchè la nostra vita spirituale possa fiorire, la confusione è completa.
Non è obbligatorio essere infelici nei nostri poveri corpi, cercando una via di fuga dal regno fisico sanzionata dallo spirito.
Non è necessario sopprimere gli istinti per dare spazio allo spirito. Si tratta di entrare gradualmente sempre più in sintonia con il corpo (che in ultima analisi è in perfetta sintonia con l’anima) consentendo ai processi mentali abituali di recedere sullo sfondo. Il corpo sa che cosa fare. Se è lasciato alle proprie risorse il corpo è miracolosamente e amorevolmente esatto nel determinare ciò di cui ha bisogno e come ottenerlo. L’anima, la spiritualità, l’affettività, l’istinto, sono organici. Per me è semplice: in connessione con la danza cosmica possiamo esserci e non esserci, nell’attimo di un respiro. Mantenendo l’anima serena libera da condizionamenti e manipolazioni,il cognitivo può affrontare ed elaborare il nuovo e lo sconosciuto.
Buongiorno a tutti voi,
il vostro articolo ‘il punto di vista degli Abhidharma’
mi ha profondamente interessato, sento una forte necessità di una buona pratica meditativa e vorrei un vostro sincero consiglio riguardo a centri molto seri in cui praticare ciò di cui parlate.
Abito vicino a Como al confine con il Canton Ticino (Svizzera) quindi posso avere accesso a due territori geografici.
Potete darmi delle indicazioni pf. grazie infinite
Cordiali saluti