Ciò che manca nel progresso tecnologico

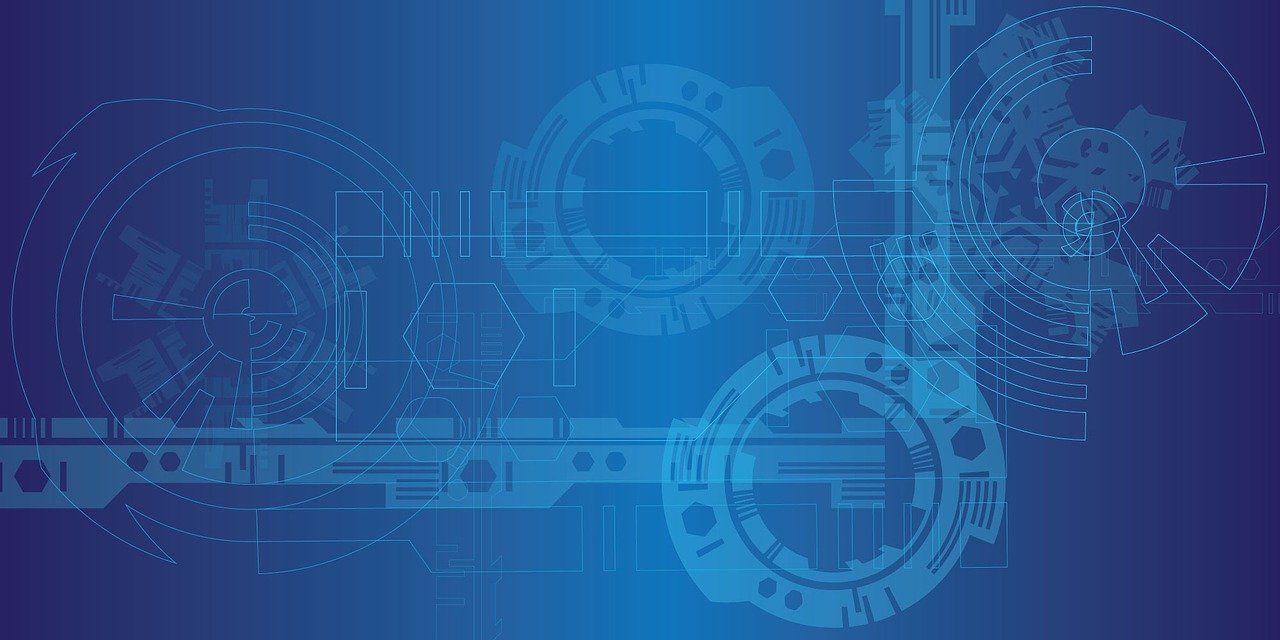
Vista da fuori, la caratteristica più impressionante dell’occidente è stata il suo dinamismo, la sua ossessione per lo sviluppo e la dominazione. Vista da dentro, la stessa caratteristica diventa la nostra fiducia nel progresso.
In particolare, negli ultimi quattro secoli, la nostra fiducia nei benefici del progresso scientifico e tecnologico. Magari non stiamo andando verso una direzione, ma stiamo fuggendo da un’altra, per evitare qualcosa che non vogliamo.
Non è troppo presto per affermare che forse la rivoluzione industriale non è stata all’altezza delle sue promesse, almeno per quanto riguarda la felicità, l’appagamento, la salute, la sanità mentale e la pace dell’uomo. Di certo, essa sta avendo un impatto terribile, e forse catastrofico, sulla Terra. La Tecnotopia sembra aver già fallito, ciononostante continui ad andare avanti, espandendo il suo raggio di azione e diventando sempre più arrogante e pericolosa. (Manner 1991, 7)
Senza tale fiducia, sarebbe molto difficile giustificare molte conseguenze di questo dinamismo: le grandi distruzioni ecologiche, la sottomissione di altre culture, il degrado sociale delle nostre comunità e così via. Ma se questi sono tutti gli effetti collaterali del progresso, OK, non possiamo fare la frittata senza rompere l’uovo!
Di sicuro, lo sviluppo tecnologico comporta dei problemi, ma per fortuna questi ultimi hanno a loro volta soluzioni tecnologiche. In altre parole, la cura per il progresso è più progresso. Ed è meglio così, perché tutti sappiamo – o siamo stati portati a credere – che è impossibile arrestare il progresso.
L’obiettivo del progresso
Il termine progresso viene dal latino “pro-gressus”, andare avanti. Ma come facciamo a dire che stiamo andando avanti, anziché indietro o di lato? Come sappiamo in quale direzione ci stiamo effettivamente dirigendo? Per restare alla metafora (sempre che serva a qualcosa), il progresso va misurato in relazione a un luogo che vogliamo raggiungere, cioè a un obiettivo.
Uno sviluppo sociale o tecnologico che ci porta più vicini a quell’obiettivo fa parte del progresso. Lo sviluppo che non ci porta più vicini a tale obiettivo non può considerarsi progressista, e se rende più difficile il suo raggiungimento, diventa regressivo.
Questo non è un discorso astratto. Se guardiamo la storia delle civiltà precedenti, vediamo che alcune culture sono state distrutte da altre, mentre altre ancora si sono distrutte da sole, spesso rovinando le proprie basi ecologiche.
Se noi stiamo progredendo, questo deve voler dire, almeno, che non stiamo seguendo le orme di quelle civiltà: cioè, il nostro progresso deve essere diverso e migliore, in modo da garantire alla nostra civiltà un destino diverso e migliore. Ma qual è questo destino speciale verso cui ci stiamo dirigendo?
Se non abbiamo alcuna idea di questo destino speciale, perché non sappiamo qual è l’obbiettivo del nostro progresso, forse la metafora del “progresso” diventa problematica. A questo punto, la prima domanda da porsi non è se stiamo andando dove vogliamo andare, ma – a un livello più fondamentale – se in generale stiamo andando da qualche parte.
Altrimenti, quale può essere mai il significato di progresso, di qualunque tipo sia quest’ultimo? E quali sono le conseguenze della mancanza di un obiettivo nella nostra ossessione per il progresso? Il fatto che tali domande sono così imbarazzanti e difficili mi porta a chiedere se forse non siamo motivati da qualcos’altro. Magari non stiamo andando verso una direzione, ma stiamo fuggendo da un’altra, per evitare qualcosa che non vogliamo.
Questo fatto, se vero, avrebbe implicazioni importanti per la nostra concezione di progresso. Se ci si vuole allontanare da qualcosa, è ovvio che possono esserci diverse strade, vari percorsi per farlo. Ma per decidere la strada migliore è importante comprendere bene cosa stiamo cercando di evitare. Altrimenti, potremmo prendere una direzione dove troveremo ancora l’oggetto-che-stiamo-cercando-di-evitare.
La possibilità peggiore è finire con il trascinarci appresso ciò di cui vogliamo liberarci, legato, per così dire, alla nostra coda. Può sembrare un modo strano di porre la questione, ma non lo è se l’oggetto da cui vogliamo scappare siamo noi, o meglio un certo aspetto di noi. In tal caso, la comprensione di noi stessi diventa più urgente di qualsiasi “progresso” intrapreso senza tale autoconoscenza.
La ragione è che tale progresso avrà probabilmente effetti collaterali piuttosto non-progressisti. Come sanno gli psicoterapeuti, quando non comprendiamo le nostre motivazioni, le nostre azioni tendono a diventare compulsive. Ciò rivela qualcosa sulla nostra attuale infatuazione per il progresso tecnologico e gli inaspettati effetti deleteri che tanto spesso sembrano seguire?
Lo sviluppo tecnologico ed economico è stato spesso elogiato dai tecnocrati perché ci porterà verso un meraviglioso futuro consistente (per esempio) in comodi e puliti grattacieli, con mezzi di trasporto che ci porteranno velocemente ovunque vogliamo andare. Ricordate il telefilm degli anni settanta The Jetsons? Quelle fantasie semplicistiche non erano un parto della mente dei disegnatori; affondavano le radici nella visione di una cornucopia (o cornutopia) tecnologica diffusa negli anni ’40-’50, quando ci veniva detto che l’energia nucleare ci avrebbe presto fornito un’elettricità così economica che era impossibile dirne il prezzo.
Quelle visioni tecnocratiche non parlavano mai di una società “in via di sviluppo”, in cui avvenivano mutamenti sociali sempre più veloci e destabilizzanti. Piuttosto, dipingevano il futuro come un mondo stabile dove la società sarebbe stata ben organizzata e la gente si sarebbe sentita sicura e felice.
È questo, allora, l’obiettivo verso cui stiamo progredendo? Se così fosse, sembrano esserci pochi punti di contatto con il modo in cui stiamo sperimentando lo sviluppo tecnologico odierno. Il nostro ambiente sociale, economico e naturale sta cambiando tanto velocemente che lo “shock del futuro” sta diventando un problema sempre più grande per molti di noi. Al contrario delle fantasie di una stabile società tecnocratica, non esiste alcun segno di un rallentamento delle trasformazioni.
Non c’è qualcosa di bizzarro in questa incongruità? Se nel mondo sviluppato tantissime persone (incluse coloro che decidono in quale direzione il mondo sviluppato continuerà a svilupparsi) stanno sperimentando agi e comodità senza precedenti, perché i mutamenti tecnologici, sociali ed economici continuano ad accelerare, anziché decelerare verso una situazione più stabile?
Inoltre, dal momento che è sempre più evidente il fatto che anche il ritmo dei cambiamenti è divenuto un problema, perché non riusciamo a rallentare? Tale ritmo è tanto frenetico non perché siamo desiderosi di condividere i benefici del progresso occidentale: il divario tecnologico ed economico tra Paesi sviluppati e sottosviluppati continua ad allargarsi. Nel frattempo, nel mondo sviluppato praticamente tutti si lamentano della velocità della vita e della mancanza di tempo.
Il fatto che apparentemente non stiamo progredendo verso un qualche mondo futuro, stabile o meno, e che non sembra esserci alcun punto di arrivo per il nostro sviluppo tecnologico (eccezione fatta per i limiti ecologici “esterni”), ci riporta alla domanda sulle nostre motivazioni.
Forse faremo un passo avanti se cercheremo di interpretare la nostra ossessione per il progresso come un riflesso della nostra insoddisfazione per il presente. Se non riusciamo a trovare una destinazione verso cui ci stiamo dirigendo, diventa più probabile l’esistenza di qualcosa da cui stiamo scappando.
Di cosa si tratta? Non può essere qualcosa che è esistito solo nel passato (per esempio, la paura della fame, oggi largamente sconfitta nei paesi sviluppati, e certamente tra le elite), perché se non fosse presente anche adesso – se non ci tormentasse tuttora – l’attuale ritmo di sviluppo tecnologico non avrebbe ragione.
No, il qualcosa da cui stiamo cercando di scappare deve continuare a motivarci, forse ora più che mai. Perché esisterebbe questa accelerazione se fosse motivata da qualcosa che sta per essere risolto? In tal caso, ci si aspetterebbe che lo sviluppo tecnologico cominci a rallentare, man mano che la soluzione comincia a imporsi. Ma che questa soluzione sia in atto, ne è certo solo qualche dogmatico (per esempio, alcuni teorici neoliberisti del libero mercato). La mia conclusione è che il nostro desiderio di progresso, e la nostra fiducia in esso, sono dovuti alla sensazione che qualcosa continua a mancarci.
Cos’è allora che ci manca? La risposta ovvia, la prima che viene alla mente, è che viviamo nella sofferenza – o almeno in un certo malessere – e il progresso è necessario per rendere più gradevole la nostra vita. Progresso vuol dire: cibo, trasporti e salute migliori, oltre a più tempo libero per divertirci.
Vogliamo più progresso perché vogliamo di più queste cose, che, evidentemente, non abbiamo in misura sufficiente. Ma se guardiamo i dati disponibili al proposito, abbiamo almeno due importanti ragioni per dubitare che siano queste le carenze alla base della nostra ossessione per il progresso.
La prima ragione è che, anche se le tecnologie moderne hanno certamente migliorato le nostre diete, è sempre più evidente che tale miglioramento ha prodotto anche notevoli e inaspettati effetti collaterali, tali da impedire al progresso di essere ciò che ci aspettavamo e, forse, che volevamo davvero.
In realtà, si potrebbe sostenere che, se avessimo conosciuto in anticipo tutte le conseguenze di questi “miglioramenti”, avremmo potuto decidere di fare a meno di alcuni di questi ultimi, oppure (se il nostro pensiero sul progresso si fosse liberato da un modello lineare) avremmo potuto decidere di migliorare gli stessi aspetti della nostra vita in altri modi. Avremmo potuto farlo, cioè, se tali sviluppi tecnologici fossero stati sottoposti a giudizio democratico prima di venire introdotti.
Per esempio, oggi abbiamo a disposizione più cibi, in varietà maggiori (anche se non sempre: per esempio, oggi è immediatamente disponibile un numero inferiore di tipi di mela) e più sicuri da certi punti di vista (anche se non da altri: si pensi alla manipolazione genetica, ai conservanti e gli altri additivi ecc.), ma generalmente meno saporiti di prima, fatto che nascondiamo usando più zucchero, sale e altri esaltatori del gusto.
Questo sembra una conseguenza del fatto che la produzione e la distribuzione del cibo sono diventate un’industria i cui prodotti hanno dovuto adattarsi ai processi industriali e alle necessità commerciali. Ma il nostro problema maggiore a questo proposito sembra essere un numero crescente di disturbi legati all’alimentazione; tra le cause, includo la crescente diffusione dei fast food.
Tutto ciò suggerisce che le tecnologie del cibo moderno non hanno in realtà migliorato il nostro rapporto con il cibo, e che qualcosa di importante è andato perduto passando dall’autoproduzione (e dalla condivisione) alle tecnologie industriali della produzione di massa.
Un discorso simile si può fare a proposito della cultura dell’automobile. Se avessimo compreso il vero prezzo dell’innegabile convenienza delle macchine – le risorse consumate da esse, l’enorme danno ecologico provocato, tutte le conseguenze della costruzione delle strade, l’effetto sugli spazi pubblici e la vita comunitaria, le implicazioni internazionali del nostro bisogno del petrolio estero e così via – non avremmo deciso di concentrarci maggiormente sul miglioramento del trasporto pubblico?
E che dire della sanità? Questo sembrerebbe un caso evidente di miglioramento dovuto alle moderne tecnologie, e fino a un certo punto è vero, ma non tanto quanto pensiamo. Ivan Illich (1977), e molti altri dopo di lui, hanno messo in evidenza come nei Paesi sviluppati una delle cause principali delle malattie sia il sistema della sanità.
Inoltre, l’enfasi sulle soluzioni tecnologiche ha spostato l’attenzione verso le cure ad alto costo piuttosto che verso la prevenzione a basso costo. I media ci bombardano di messaggi “per il bene pubblico” in cui la colpa del cancro e di altre malattie del sistema immunitario viene attribuita al nostro stile di vita (troppo tabacco, alcol, grassi e zuccheri; poco esercizio fisico ecc.), distogliendo la nostra attenzione dalle cause sociali come l’inquinamento.
Siamo perfino giunti a dare per scontata una cultura della pillola, dove gli effetti collaterali di ciascuna pillola vanno curati da altre pillole, i cui effetti collaterali vanno a loro volta curati. L’effetto cumulativo di queste pillole e di altri interventi migliora il particolare problema di salute che stiamo affrontando, ma non provoca necessariamente un migliore stato di salute generale. Di nuovo, se avessimo saputo tutto ciò, non avremmo fatto meglio a creare una cultura medica meno tecnologica e che ponesse l’accento sulla prevenzione (assumendo, ancora una volta, di aver avuto una possibilità di scelta)?
Infine: tutte le moderne tecnologie che dovevano dispensarci dal lavoro, ci hanno dato ciò che promettevano, cioè una vita più comoda? Una simile affermazione è difficile da difendere, perché ha moltissime prove contrarie. Uno studio del 1992 dello U.S. National Recreation and Park Association ha scoperto che il 38 per cento degli americani sente di andare sempre di fretta, contro il 22 per cento del 1971.
In The Overworked American (1992), Juliet Schor ha affermato che gli americani stanno lavorando molto di più, e più recentemente, in “Utne Reader”, Joe Robinson (2000) ha sostenuto che gli Stati Uniti sono diventati il Paese nel mondo industrializzato dove si lavora di più, superando il Giappone. Secondo Robinson, marito e moglie di una famiglia americana media lavorano circa 500 ore all’anno in più che nel 1980. I sondaggi di Lou Harris mostrano, negli ultimi venti anni, una diminuzione del tempo libero pari al 37 per cento (Levine 1997, 107). Il contrasto con la vita delle “popolazioni primitive” è stridente:
Il tempo è uno dei molti lussi che le popolazioni indigene godono più di noi. Per questo, le comunicazioni sono spesso caratterizzate da una deliberata lentezza: le persone non hanno fretta. Non sono interessate a guadagnare più o meno tempo (cioè, all’«efficienza»), perché c’è abbastanza tempo per fare ciò che va fatto. Si godono il tempo per sé che la mancanza di fretta concede. Quando occorre fare qualcosa, la si fa operando di concerto in gruppo. (Mander 1991, 66)
Se esiste un rapporto tra il tempo libero e il ritmo delle trasformazioni tecnologiche, esso sembra inversamente proporzionale: tanto più è “avanzata” la nostra tecnologia, tanto minore sembra il tempo libero a nostra disposizione. Una ragione è che tutte queste macchine che ci fanno risparmiare tempo hanno bisogno di controlli e riparazioni.
Per esempio, oltre al tempo che tutti passiamo davanti al computer, dobbiamo calcolare quello impiegato per aggiornare, riparare e sostituire quest’ultimo, per non parlare del tempo speso a guadagnare i soldi necessari al suo acquisto.
I mass media celebrano entusiasticamente l’avvento delle nuove tecnologie, ma se consideriamo gli esempi suddetti, è difficile evitare la conclusione che il nostro “progresso” tecnologico non è stato progressista come avremmo voluto. Le scoperte più importanti hanno gettato una lunga e oscura ombra, che però si è manifestata troppo tardi per provocare l’eliminazione o la trasformazione delle relative tecnologie. O, almeno, questo è quello che ci hanno fatto credere.
Esiste un altro motivo per dubitare del fatto che il desiderio di agi e comodità rappresenti il motivo della nostra infatuazione per le nuove tecnologie. Il fatto cruciale è che abbiamo passato il punto dei rendimenti decrescenti: la comodità maggiore di qualsiasi nuovo ritrovato non basta a giustificare l’aumento di stress nella nostra vita.
Per dirla con altre parole, se gli agi e le comodità sono ciò che ci manca, e se questo è il problema che il progresso tecnologico ed economico deve risolvere, quest’ultimo non ci sta più riuscendo molto bene. Se queste sono le definizioni del progresso e della felicità, oggi il progresso non ci sta rendendo più felici. Secondo la Relazione sullo sviluppo umano delle Nazioni Unite del 1999, la percentuale di americani che si considerava felice ha raggiunto il valore massimo nel 1957, nonostante il fatto che da allora i consumi pro capite sono più che raddoppiati.
Il principale indicatore statistico del progresso usato dai governi, il prodotto interno lordo, è ovviamente inadeguato, e viene sempre più percepito come tale, in quanto si limita a misurare il valore monetario dei beni e servizi prodotti. Cioè, non tiene in conto se ho divorziato in modo non consensuale da mia moglie nello stesso momento in cui mi è stata diagnosticata una grave malattia dalle cure lunghe e costose.
Anche indici alternativi che considerano fattori come il benessere sociale e la qualità ambientale mostrano una minore qualità della vita, negli Stati Uniti e nella Gran Bretagna, durante la seconda metà del ventesimo secolo: dalla metà degli anni settanta, secondo l’Indice di Benessere Economico Sostenibile (ISEW in inglese), e dal 1950, secondo il più recente Indice del Progresso Genuino (GPI) (Jackson et al. 1997; Coob et al. 1995).
Poiché tali problemi sono sempre più evidenti, la conseguenza ovvia sembrerebbe che dobbiamo fermarci a considerare il loro significato; al contrario, il mondo continua ad andare sempre più veloce.
Se i nuovi ritrovati non ci rendono felici, è possibile che sviluppiamo un’ossessione nei loro confronti perché non sappiamo cos’altro fare della nostra vita? Sfortunatamente, sembra esserci un rapporto inverso tra l’infatuazione occidentale per il progresso tecnologico e il nostro scarso desiderio di comprendere tale infatuazione.
In breve: sembra improbabile che la nostra infatuazione per la tecnologia e la nostra ossessione per il progresso siano motivate dal semplice desiderio di un numero maggiore di beni materiali. Se vogliamo comprendere cosa ci manca (o cosa riteniamo che ci manca), dobbiamo cercare da un’altra parte. Può essere che stiamo davvero cercando di scappare da qualcosa, e non ci riusciamo perché lo stiamo facendo nel modo sbagliato? Tale conclusione chiama in causa quella che la psicoanalisi definisce repressione, ma qui possiamo anche trarre spunto anche dal punto di vista buddista.
La mancanza dell’io
Qual è la nostra comprensione di “anatta”, il non-io, quello strano insegnamento buddista secondo cui non esiste l’io che diamo per scontato nella nostra vita quotidiana? Il buddismo analizza il cosiddetto io all’interno dei fenomeni psicofisici impersonali (“skandhas”), le cui interazioni creano l’illusione che la consapevolezza sia l’attributo di un io.
Altrove ho sostenuto che l’idea psicoanalitica della repressione può aiutarci a comprendere la nostra percezione illusoria di un io separato (Loy 1999). L’enfasi buddista su “anatta” implica che la nostra repressione fondamentale non riguarda i desideri sessuali (come credeva Freud) e nemmeno la morte (come ritengono molti psicologi esistenziali), ma piuttosto la consapevolezza del non-io, cioè la sgradevole scoperta che il mio senso-dell’-io non è qualcosa di esistente, ma un costrutto mentale condizionato e privo di fondamento.
Poiché tale comprensione ci provoca un grande disagio, la neghiamo reprimendola; ma come ha sottolineato Freud, ciò che viene represso tende a tornare alla coscienza distorto in sintomi. In tal caso, l’intuizione del mio non-io ritorna come “senso di mancanza”: la sensazione che “in me c’è qualcosa di sbagliato”.
Tale senso di mancanza, che interpretiamo in modi diversi a seconda della situazione (Non sono abbastanza ricco, abbastanza famoso ecc.), è un sintomo, perché rappresenta il modo distorto in cui sperimentiamo la nostra inconsistenza. Ovvero, per usare termini più buddisti, è il modo in cui cerchiamo di evitare il nostro vuoto (“sunyata”).
Un altro modo di descrivere tale senso di mancanza è dire che non ci sentiamo sufficientemente veri. In questo caso, la soluzione è (ovviamente) diventare più autentici; o almeno questo è quello che ci sembra.
Se la nostra mancanza di radici ci riesce tanto sgradevole, la soluzione è sviluppare radici, giusto? Ma il problema di questa soluzione è che, secondo la definizione di “anatta”, il mio senso dell’io, “vuoto” e condizionato, è privo di radici per natura. Poiché il senso-dell’-io è un costrutto sempre precario, i miei sforzi per real-izzarmi diventano tentativi di oggettivarmi in qualche modo nel mondo, ma questo è qualcosa che non potrò mai fare, non più di quanto la mia mano può afferrare se stessa o il mio occhio vedere se stesso.
In breve, il vuoto senso-dell’-io comporta, come sua inevitabile ombra, un senso-di-mancanza che si cerca sempre di evitare. Quello che Freud definiva “il ritorno della repressione nella forma distorta di un sintomo”, ci mostra come connettere questo processo (basilare ma senza speranza) con i modi simbolici in cui cerchiamo, secondo le nostre possibilità. di renderci reali nel mondo.
Il problema di tutti questi tentativi è che nessuna oggettivazione può mai essere soddisfacente, se quello che desideriamo davvero non è un oggetto. E quando non comprendiamo cosa ci motiva davvero – perché quello che pensiamo di volere è solo un sintomo di qualcos’altro (il nostro desiderio di divenire reali, che è essenzialmente un’aspirazione spirituale) – il nostro comportamento diventa compulsivo.
Secondo Nietzsche, il cristiano che segue l’ammonimento biblico e si strappa l’occhio non uccide la sua sensualità, perché quest’ultima “continua a vivere in una misteriosa forma vampiresca e lo tormenta sotto spoglie repellenti”. Ma è vero anche l’opposto: se oggi pensiamo di aver ucciso o altrimenti evitato la nostra aspirazione spirituale, ci stiamo ugualmente illudendo, perché quell’aspirazione prospera in misteriose forme secolari che ci ossessionano, dal momento che non ne comprendiamo i motivi. La nostra ossessione per il progresso tecnologico è una di queste? La nostra “mancanza” ha anche implicazioni sociali e storiche? Esiste qualcosa come una “mancanza collettiva”?
La religione è il modo tradizionale con cui le società hanno affrontato il senso di mancanza (per esempio, il peccato cristiano). La società europea occidentale si basava su un paradigma religioso del genere, fino a che qualcosa di nuovo cominciò ad accadere nell’undicesimo secolo: la possibilità di un progresso verso una soluzione alternativa.
Come si è formata la nostra ossessione per lo sviluppo tecnologico? Come è stata possibile l’evoluzione di un paradigma secolare da uno religioso? Come siamo arrivati a cercare soluzioni secolari per quello che è essenzialmente un problema spirituale? La curiosa risposta è che la soluzione del “progresso” non era, in origine, secolare.
Negli anni tra il 1050 e il 1150, la soluzione europea religiosa alla “mancanza” cominciò a spostarsi da un “mondo superiore” a questo mondo; non si guardava più in su, verso il paradiso, ma in basso, a ciò che sarebbe potuto accadere sulla Terra nel futuro. Lo spostamento fu graduale. All’inizio si poneva l’accento sulla creazione delle condizioni che avrebbero potuto accelerare il ritorno di Cristo e il nuovo millennio da lui inaugurato.
Alla fine cominciammo ad acquistare più sicurezza nella nostra capacità di trasformare la società e le condizioni materiali della nostra esistenza. Ciò implicava una nuova concezione della temporalità e della tecnologia. Tale concezione si basava sul “senso comune” e quindi era dimentica delle motivazioni spirituali da cui, originariamente, si era sviluppata.
L’epoca del progresso
La concezione umana del tempo è sempre collegata alla nostra concezione della “mancanza” e dei modi per risolvere quest’ultima. Ciò vuol dire che nelle società tradizionali, incluso l’occidente premoderno, la struttura del tempo è fondamentalmente religiosa.
Nelle società moderne, il tempo non è altro che una griglia astratta e impersonale per coordinare gli eventi che accadono in questo mondo (per esempio, il giorno di 24 ore e l’anno di 365 giorni, dove ogni ora e ogni giorno sono uguali a tutti gli altri e rappresentano un’unità oggettiva di misura del tempo che non ha un significato in sé).
Al contrario, lo schema tradizionale del tempo fornisce un modello sacro che dà senso agli eventi di questo mondo: “Il soprannaturale e il passaggio del tempo rappresentato dal ciclo annuale erano tanto strettamente collegati da risultare indistinguibili” (Thompson 1996, 2).
Secondo tale concezione, quando in questo mondo c’è qualcosa di sbagliato, è a causa della sua disarmonia con il mondo soprannaturale, e la soluzione non è il “progresso”, ma il ripristino dell’armonia tramite il rinnovamento o il ristabilimento del giusto modello di tempo: per esempio, facendo sacrifici nel modo giusto al momento giusto. Al contrario della nostra successione lineare di eventi basati sulla causa e l’effetto, che usiamo per cambiare il mondo, questa temporalità associativa considera inseparabili la storia e la cosmologia.
Non esiste distinzione tra il tempo e ciò che accade nel tempo (o ciò che dovrebbe accadere nel tempo). Rituali come i sacrifici di purificazione vengono praticati in base a fenomeni naturali ciclici, perché sono necessari in quei momenti. Ovvero, tali rituali non accadono in quei periodi, ma (se gli uomini stanno facendo ciò che dovrebbero fare) fanno parte di quei periodi (Aveni 1995, 65).
Secondo Mircea Eliade, le società arcaiche vivevano in un “paradiso di archetipi”, perché la loro struttura del tempo si basava su una periodica rigenerazione della creazione osservata nella natura (Aveni 1995,65). Tale temporalità presuppone che ogni ri-creazione ripete l’atto iniziale della genesi. Ri-costruendo il mito della creazione, i partecipanti rivivevano la creazione dell’ordine dal caos, del significato dall’assenza di significato.
Tali eventi non si trasformarono mai in passato, almeno in quello che noi definiamo tale, cioè qualcosa di storicamente soppiantato dal presente. Mentre noi inseguiamo il progresso scegliendo di separarci dagli eventi passati, le società più tradizionali negano tale dualità riportando in vita il passato. È loro responsabilità agire così, ricreando quella creazione che fa sì che il mondo continui ad andare come sempre. Per loro, il passato non è un peso da superare, né il futuro è un insieme di possibilità da realizzare. È sufficiente ripetere l’antico modello.
I Maya, una delle culture più ossessionate dal tempo, forniscono un buon esempio. Essi non misuravano il tempo con il sole: il tempo era il ciclo del sole. Per loro, il giorno non rappresenta un dio, come accade (o accadeva) per noi (Giovedì viene da il dì di Giove). Per i Maya, ciascun giorno è Dio.
Per conservare la relazione parallela tra gli umani e il mondo soprannaturale, è necessaria una grande attenzione alle richieste di ogni giorno. Il passato continua a ripetersi nel presente perché gli eventi della vita sono scrupolosamente calcolati e regolati; solo intrecciando le due dimensioni è possibile mantenere l’ordine del cosmo. In una tale concezione del mondo, il futuro è poco importante, in quanto gli eventi significativi continueranno a ripetersi finché sarà mantenuto lo stesso equilibrio di forze cosmiche (Aveni 1995, 190ff).
“Partecipando ai rituali, essi aiutavano gli dei della natura a portare i loro pesi lungo il difficile tragitto, perché credevano fermamente che i rituali servivano a chiudere formalmente i cicli del tempo. Senza il lavoro della loro vita, l’universo non poteva funzionare correttamente” (252). In tali società non c’è bisogno di progresso, né esiste spazio per esso. Quindi, come è nata la nostra infatuazione per il progresso?
Fin quasi verso l’undicesimo secolo, anche l’Europa concepiva il tempo come un modello creatore-di-significato da ri-portare in vita. “Comprendere il nostro tempo equivale a tracciare la storia dell’occidente giudeo-cristiano” (Aveni 1995, 12). La nostra settimana ha sette giorni perché in tal modo si ripete il modello della creazione all’inizio del libro della Genesi; gli ebrei adorano e riposano al sabato perché in quel giorno il Signore si è riposato (i primi cristiani lo cambiarono con la domenica, perché in quel giorno Cristo resuscitò dai morti per divenire la luce del mondo).
Il ciclo annuale delle commemorazioni della chiesa cattolica rivela ancora le sue origini associative. In breve, il primo medioevo conservò la nondualità tra la cosmologia e la storia, con una importante differenza. Per i popoli tradizionali come i Maya, la fine del tempo, che si sarebbe potuta verificare qualora fossero cessati i continui sacrifici per mantenere il dio-sole nel suo corso, sarebbe stata la più grande catastrofe immaginabile. Per i cristiani, la seconda venuta del Cristo era una salvezza desiderabile. Questa si rivelò una differenza cruciale.
I primi cristiani ritenevano che il ritorno di Cristo fosse imminente. Il fatto che ciò non avvenne venne spiegato in molti modi, ma per tutto il medioevo e la prima modernità si ebbero continui ritorni del millenarismo. Il millenarismo apocalittico (presente periodicamente in molte religioni, non solo nel cristianesimo) si può definire come la certezza che la tensione tra il mondo corrotto e quello soprannaturale si risolverà nel (prossimo) futuro, quando il trascendente si manifesterà così completamente che questo mondo sarà purificato e trasformato.
Il passo cruciale verso l’era moderna e il nostro orientamento progressista fu l’idea di un aureo futuro non al di fuori della temporalità umana, ma dentro di essa. Tale idea venne adottata da Gioacchino da Fiore (1135-1202), un importante abate ed eremita calabrese, le cui complesse visioni riunivano tutti i diversi filoni della rivelazione e della storia.
Gioacchino mantenne la credenza tradizionale secondo cui gli eventi sulla Terra corrispondono a quanto sta avvenendo su un’altra dimensione, ma allo stesso tempo immaginò una perfetta utopia cristiana nel futuro della Terra. Secondo la sua esegesi, l’antico testamento corrispondeva all’Era del Padre, mentre il nuovo testamento a quella del Figlio; l’Era Finale è quella dello Spirito, che secondo lui sarebbe arrivata intorno al 1260 e sarebbe stata un’era di immensa felicità nella quale una Chiesa rinnovata avrebbe regolato tutti gli aspetti della vita.
“Senza saperlo, egli aveva creato il legame cruciale tra il cambiamento apocalittico e la ricostruzione politica. Dal tredicesimo secolo in poi, le due realtà non avrebbero più potuto essere realmente separate” (Thompson 1996, 128). Erano state gettate le basi del percorso che sarebbe culminato nella nostra prediletta fiducia nel progresso. Esso sarebbe sorto “dalla fede cristiana che tutte le cose sono fatte espressamente per il loro fine… La fede nella Seconda Venuta proietta il credente in avanti, verso il giudizio finale che dà senso a tutto.
Nell’epoca moderna, questa nozione di avanzamento lungo una linea temporale è ancora prevalente, con la differenza che la tecnologia ha sostituito la religione come forza che muove gli eventi uno dopo l’altro; ciononostante, la dottrina resta teologica” (128).
Ben lungi dall’essere alternative razionali all’«apocalitticismo» religioso, “molte idee che consideriamo l’opposto di ciò che è «medievale», come la fede nel progresso e la promessa di un’utopia, hanno radici nell’epoca di mezzo, e nella credenza della Fine del Tempo” (57).
Le radici spirituali della tecnologia
Se per molti di noi la religione è stata sostituita dalla tecnologia, ciò potrebbe essere avvenuto perché il nostro atteggiamento verso quest’ultima ha radici religiose simili. Il libro di David Noble The Religion of Technology (1998) dimostra che la nostra infatuazione contemporanea per la tecnologia ha radici nel mito religioso e nella ricerca della salvezza spirituale.
“I tecnologi di oggi, anche se nella loro sobria ricerca dell’utile, del profitto e del potere sembrano aver creato una società razionale, in realtà sono pilotati da sogni lontani, da aspirazioni spirituali verso una redenzione soprannaturale… La loro aspirazione autentica riguarda… una persistente e oltremondana ricerca della trascendenza e della salvezza” (3). Coloro che fantasticano di “scaricare la propria mente” in megagigabyte di hard drive possono ritenersi razionalisti antireligiosi, ma l’escatologia religiosa può assumere vesti imprevedibili. Forse abbiamo dimenticato le nostre motivazioni originali, ma questo non vuol dire che esse non esistano più.
Nel periodo medievale, “per ragioni che restano oscure” (Noble 1998, 12), sono cominciati ad avvenire importanti cambiamenti nell’atteggiamento cristiano verso la tecnologia. La società medievale credeva che parte della propria decadenza fosse dovuta allo smarrimento delle antiche arti e scienze.
La novità fu la convinzione che tali arti meccaniche potevano e dovevano essere riportate in vita, non tanto (in un primo momento) per migliorare le nostre condizioni terrene, quanto per accelerare il ritorno del Cristo. “Con il tempo, la tecnologia cominciò a essere identificata sia con la perfezione perduta che con la possibilità di riottenere quest’ultima. Il progresso delle arti assunse un nuovo significato: non solo come una prova della grazia, ma come un mezzo di preparazione all’imminente salvezza, oltre che come un sicuro segno di quest’ultima”. L’influente monaco agostiniano Ugo di San Vittore (1096-1141) sottolineò che “Il lavoro di ripristino includeva la riparazione della vita fisica dell’uomo”, che era stata danneggiata dal peccato e perduta con la Caduta (12, 19-20).
Una reinterpretazione e rivitalizzazione elitaria della prima fede cristiana… situò il processo di recupero nel contesto della storia umana, ridefinendolo come una ricerca conscia e attiva, piuttosto che come un’aspettativa meramente passiva e cieca… Il recupero dell’aspetto divino dell’uomo, la traiettoria trascendente del cristianesimo, divenne così allo stesso tempo un progetto immanente e storico… La tecnologia era divenuta allo stesso tempo un’escatologia (22).
Noble definisce l’interpretazione di Gioacchino del Libro della Rivelazione “il più influente sistema profetico conosciuto in Europa prima del marxismo” (1998, 24). Esso “alimentò la più grande rivoluzione spirituale del Medio Evo” rivelando il significato millenaristico della storia, il piano di Dio per l’umanità. Tutti gli uomini sapienti, ha scritto Robert Bacon, credono che l’epoca dell’anticristo sia vicina, e Bacon stesso spinse i suoi colleghi ecclesiastici a studiare le profezie di Gioacchino, per conoscere in anticipo gli eventi finali della storia.
In seguito, persino Francis Bacon, il profeta della scienza moderna, ha cercato “un ritorno allo stato di Adamo prima della Caduta, uno stato, puro e libero dal peccato, di unione con la natura e di conoscenza dei suoi poteri… Un progresso all’indietro, verso Adamo” (Francis Yates, in Noble 1998, 50). Sia Robert Boyle che Isaac Newton erano ferventi millenaristi, e quest’ultimo trascorse molto tempo a interpretare le profezie bibliche.
Per loro, come per molti altri scienziati degli inizi, l’indagine scientifica era uno sforzo devoto di avvicinamento al Creatore, grazie alla scoperta della sua “firma” nel mondo naturale (64). “Armati di tali conoscenze sul futuro, tra cui quella del loro ruolo designato, gli eletti non avevano più bisogno di aspettare passivamente il millennio; ora essi potevano agire attivamente per provocarlo” (24-25). Oggi stiamo ancora lavorando in questo senso, ma nel frattempo abbiamo dimenticato che cosa, esattamente, stiamo cercando di provocare. È questo il motivo per cui il nostro progresso sempre più veloce non riesce ad avere un punto di arrivo?
Abbiamo dimenticato cosa stiamo facendo perché abbiamo frainteso la nostra “mancanza”, e quindi la soluzione a quest’ultima. La nostra mancanza, invece di essere il nodo tra la creazione e la storia (come riteneva il cristianesimo tradizionale) è stata marginalizzata dalla nostra ossessione per il potere e il potenziale della tecnologia. Per la nostra salvezza non dipendiamo più dalla struttura del cosmo, ma cerchiamo di raggiungerla da soli.
In luogo della tradizionale nondualità tra il cosmo e la storia – che ci fornisce un intricato percorso a ostacoli da seguire secondo ruoli prefissati – abbiamo cominciato a vivere in un universo aperto, in cui dobbiamo decidere gli obiettivi e la direzione in cui procedere. Abbiamo deciso di entrare nel futuro e di chiamare progresso il nuovo gioco.
La fine del gioco?
Questo gioco sta per finire? Il futuro inizia a non esercitare più la sua attrazione, il che vuol dire che il nostro senso collettivo di mancanza sta cominciando a staccarsi da quegli aspetti economici e tecnologici per mezzo dei quali sperava di diventare reale. Ma poiché non abbiamo più fede in una soluzione spirituale, restiamo intrappolati nel futuro. Infatti, solo tramite esso sappiamo affrontare il nostro senso di mancanza. “Progrediamo” sempre più velocemente perché non sappiamo cos’altro fare e a cos’altro giocare.
Più abbiamo il sospetto di non stare andando da nessuna parte, più dobbiamo correre velocemente. Le implicazioni tecnologiche ed economiche della crisi ecologica sono state ignorate o represse nell’ultimo decennio, almeno negli Stati Uniti, ma ciò non può andare avanti all’infinito. Sempre meno persone credono che la tecnologia risolverà i problemi del mondo, portando a una vita migliore. La collettiva mancanza di progettualità dello sviluppo tecnologico sta cominciando a essere messa in discussione da un numero crescente di pensatori. Ma per chi controlla i governi e le aziende, lo stadio finale del “progresso” è diventato un gioco di numeri relativo alla crescita economica, misurato dal prodotto interno lordo.
L’altra alternativa culturale è il nichilismo, che assume forme diverse e sta diventando molto diffuso. Esso consiste nell’abbandono di ogni speranza di una possibile soluzione alla nostra mancanza. Poiché ciò priva la vita di ogni significato, l’unica cosa da fare è divertirci finché possiamo.
Quali sono gli altri paradigmi possibili per risolvere la mancanza? Poiché ho illustrato il problema da una prospettiva buddista, concludo menzionando la soluzione buddista, che contempla lo sforzo personale di trasformare noi stessi; o, piuttosto, di lasciarci trasformare, cosa che avviene, per esempio, quando meditiamo. Il fine della pratica buddista è trasformare i tre veleni dell’avidità, la cattiva volontà e l’illusione nella generosità, la compassione e la saggezza. Per la terza trasformazione, non dobbiamo acquisire, bensì lasciare andare qualcosa: non tanto pensieri e sentimenti particolari, quanto, fondamentalmente, il nostro senso-dell’-io.
La negazione buddista di un io sostanziale (“anatta”) rende possibile una trascendenza in questo mondo dell’io, grazie alla comprensione dell’interdipendenza nonduale tra un soggetto non-più-alienato e un mondo non-più-oggettivato. Il risveglio buddista accade quando comprendo di non essere altro che quel mondo.
Questo si può esprimere dicendo che io sono ciò che il mondo sta facendo qui e ora. Tale liberazione mi dispensa dal tentativo, ossessivo e continuo, di acquisire radici. Se “io” non sono dentro il “mio” corpo, allora, guardando il mondo esterno, l’«io» non ha bisogno di mettermi al sicuro. Una volta che “io” ho compreso ciò, lasciandomi andare, non c’è nulla che vada reso “reale” o che vada perduto.
Quindi, l’ironia finale del mio tentativo di radicarmi – di cercare di sentirmi reale riempiendo il mio senso di mancanza – è che non può avere successo, in quanto ho già radici nella totalità. Non ho radici né posso averle nella misura in cui mi sento separato dal mondo; ma ho sempre avuto radici nella misura in cui sono nonduale rispetto a esso. La mia mancanza è tale solo finché ne ho timore e cerco di riempirla.
Quando cesso di farlo, tale mancanza si trasforma nella fonte della mia energia creativa, che scaturisce da una fonte insondabile. Secondo il buddismo, tale risveglio è spontaneamente accompagnato dalla compassione per tutti gli esseri, non più percepiti come altro da me.
Sperare che tale liberazione possa diffondersi nell’immediato futuro è troppo, ma se questa possibilità venisse socialmente riconosciuta, e più largamente incoraggiata e apprezzata, le conseguenze sarebbero indubbiamente immense. Che questa sia o meno una possibilità collettiva per l’umanità, a questo punto del nostro sviluppo culturale, è un’altra questione, benché l’inizio di un nuovo millennio incoraggi tali speculazioni millenaristiche. Se il nostro bisogno è un’indicazione, è tempo di una trasformazione radicale.
Nessuno può vivere senza una fede nella vittoria finale di qualcosa. Rosenstock-Huessy
Bibliografia e citazioni
Aveni, A. 1995. Empires of time. New York: Kodanska.
Cobb, C., et al. 1995. The genuine progress index. San Francisco: Redefining Progress.
Illich, I. 1977. Limits to medicine. Harmondsworth, N.Y.: Penguin.
Jackson, T., et al. 1997. Index of sustainable economic welfare for the U.K. 1950-96. Guildford, U.K.: University of Surrey.
Levine, R. 1997. A geography of time. New York: Basic Books.
Loy, D. R. 1999. Lack and transcendence. Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1996. Reprint, Amherst, N.Y.: Humanity Books.
Mandre, J. 1991. In the absence of the sacred. San Francisco: Sierra Club Books.
Nazioni Unite. United Nations Human Development Report for 1999. Consultabile su http://www.undp.org/hdro/overview.pdf
Nietzsche, F. 1986. Human, all too human. Tradotto da R. J. Hollingdale. New York: Cambridge University Press.
Noble, D. F. 1998. The religion of technology. New York: Knopf.
Robinson, J. 2000. Four weeks vacation “Utne Reader”, settembre-ottobre.
Schor, J. 1992. The overworked American. New York: Basic Books.
Thompson, D. 1996. The end of time. London: Minerva.
David R. Loy è professore di studi internazionali alla Bunkyo University di Chigasaki, in Giappone. È autore di Nonduality (1989) e A Buddhist History of the West (2002). Ha studiato lo zen per molti anni ed è un “sensei” della scuola Sanbo Kyodan.
Ordina i libri con InternetBookshop
Anthony Aveni. Gli imperi del tempo. Calendari, orologi e culture. Dedalo. 1993. ISBN: 8822005333
Robert Levine. Una geografia del tempo. Fioriti. 1998. ISBN: 8887319049
Ordina i libri con Amazon
David R. Loy. Nonduality: A Study in Comparative Philosophy. Humanity Books. 1999. ISBN: 1573923591
Copyright originale Helen Dwight Reid Educational Foundation. Pubblicato originalmente su ReVision magazine volume 24 n.4, spring 2002, edito da Heldref Publications, 1319 Eighteenth St., NW, Washington, DC 20036-1802 http://www.heldref.org/html/rev.html
Traduzione di Gagan Daniele Pietrini
Copyright per l’edizione italiana: Innernet.










